
 Romanziere, drammaturgo, sceneggiatore per il cinema e la televisione, conduttore televisivo e molto altro: Carlo Lucarelli è uno degli autori che ha maggiormente contribuito al successo internazionale del romanzo giallo italiano contemporaneo. In occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, lo scrittore è stato ospite, nella capitale boema, per un incontro sul tema: “Il romanzo giallo italiano contemporaneo” che si è tenuto nella splendida Cappella Barocca dell’Istituto attualmente diretto da Alberta Lai. Dalla penna di Lucarelli sono nate figure di indimenticabili investigatori-investigatrici al centro di popolari serie di romanzi tradotti in molte lingue, quali l’Ispettrice Grazia Negro: Lupo Mannaro (1994), Almost Blue (1996), Un giorno dopo l’altro (2000), Il sogno di volare (2013), Léon (2021); l’Ispettore Coliandro: Falange armata (1993) e Il giorno del lupo (1994); il Commissario De Luca: Carta bianca (1990), L’estate torbida (1991), Via delle oche (1997), Intrigo italiano (2017), Peccato mortale (2018) e L’inverno più nero (2020). Molti di questi romanzi sono diventati film per la TV di cui l’autore ha curato anche la sceneggiatura.
Romanziere, drammaturgo, sceneggiatore per il cinema e la televisione, conduttore televisivo e molto altro: Carlo Lucarelli è uno degli autori che ha maggiormente contribuito al successo internazionale del romanzo giallo italiano contemporaneo. In occasione delle celebrazioni per i 100 anni dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, lo scrittore è stato ospite, nella capitale boema, per un incontro sul tema: “Il romanzo giallo italiano contemporaneo” che si è tenuto nella splendida Cappella Barocca dell’Istituto attualmente diretto da Alberta Lai. Dalla penna di Lucarelli sono nate figure di indimenticabili investigatori-investigatrici al centro di popolari serie di romanzi tradotti in molte lingue, quali l’Ispettrice Grazia Negro: Lupo Mannaro (1994), Almost Blue (1996), Un giorno dopo l’altro (2000), Il sogno di volare (2013), Léon (2021); l’Ispettore Coliandro: Falange armata (1993) e Il giorno del lupo (1994); il Commissario De Luca: Carta bianca (1990), L’estate torbida (1991), Via delle oche (1997), Intrigo italiano (2017), Peccato mortale (2018) e L’inverno più nero (2020). Molti di questi romanzi sono diventati film per la TV di cui l’autore ha curato anche la sceneggiatura.
Lei è ormai uno scrittore “noir” di culto in Italia, un punto di riferimento imprescindibile per quanto riguarda questo genere letterario e non solo, ma il suo percorso narrativo parte da lontano, si va dai racconti brevi nelle varie antologie del “Gruppo 13”, alla trilogia giallo-storica con il commissario De Luca, Carta bianca, L’estate torbida, Via delle Oche e così via, passando per Almost Blue. Da Carta Bianca a Léon, come si sono evolute la scrittura e la facoltà creativa di Lucarelli?
 “Evolute” è una bella parola. Direi che si sono evolute come succede per tutti gli scrittori che tentano di sperimentare cose diverse, come è successo a me e a tanti altri miei colleghi. Quando ho iniziato a scrivere Carta bianca, e i primi romanzi con il Commissario De Luca, pensavo che quello sarebbe stato il mio stile, il mio personaggio e il mio modo di raccontare delle storie. Storie ambientate nel passato, che però raccontavano anche l’Italia di oggi, con un commissario di polizia con tutte le sue contraddizioni, e con uno stile molto piano, “quadrato”, direi. Poi, però, una volta scritti i primi due romanzi, mi è venuta in mente una storia che De Luca non avrebbe potuto raccontare. Ed era la storia della “Uno bianca” di Bologna. Lì c’era bisogno di un altro personaggio, e così è venuto fuori l’Ispettore Coliandro, sempre un poliziotto, ma con uno stile tutto diverso. Un personaggio che dice parolacce, un personaggio molto contemporaneo. Ma poi mi è venuta in mente ancora un’altra storia ambientata nel passato, e così è tornato De Luca. Ma è tornato dopo che io avevo fatto altre esperienze: Coliandro e qualche altro romanzo. E quindi anche quel De Luca si è preso alcune delle esperienze fatte. Poi è arrivato un altro personaggio ancora: Grazie Negro, con un nuovo sviluppo, per raccontare una Bologna inquieta che Coliandro non avrebbe capito e che De Luca non ci sarebbe neanche stato per poterla raccontare. Quindi, alla fine, si è evoluto così il mio stile. Per esperimenti fatti tutti soprattutto nel campo della scrittura.
“Evolute” è una bella parola. Direi che si sono evolute come succede per tutti gli scrittori che tentano di sperimentare cose diverse, come è successo a me e a tanti altri miei colleghi. Quando ho iniziato a scrivere Carta bianca, e i primi romanzi con il Commissario De Luca, pensavo che quello sarebbe stato il mio stile, il mio personaggio e il mio modo di raccontare delle storie. Storie ambientate nel passato, che però raccontavano anche l’Italia di oggi, con un commissario di polizia con tutte le sue contraddizioni, e con uno stile molto piano, “quadrato”, direi. Poi, però, una volta scritti i primi due romanzi, mi è venuta in mente una storia che De Luca non avrebbe potuto raccontare. Ed era la storia della “Uno bianca” di Bologna. Lì c’era bisogno di un altro personaggio, e così è venuto fuori l’Ispettore Coliandro, sempre un poliziotto, ma con uno stile tutto diverso. Un personaggio che dice parolacce, un personaggio molto contemporaneo. Ma poi mi è venuta in mente ancora un’altra storia ambientata nel passato, e così è tornato De Luca. Ma è tornato dopo che io avevo fatto altre esperienze: Coliandro e qualche altro romanzo. E quindi anche quel De Luca si è preso alcune delle esperienze fatte. Poi è arrivato un altro personaggio ancora: Grazie Negro, con un nuovo sviluppo, per raccontare una Bologna inquieta che Coliandro non avrebbe capito e che De Luca non ci sarebbe neanche stato per poterla raccontare. Quindi, alla fine, si è evoluto così il mio stile. Per esperimenti fatti tutti soprattutto nel campo della scrittura.
Come è arrivato al genere “noir” e alla passione per il “mistero”, e quali sono stati i suoi punti di riferimento letterari e di ispirazione per la scrittura?
Al genere “noir” ci sono arrivato da lettore, come tanti. Mia madre era una grande lettrice, leggeva romanzi di ogni genere, e ogni volta che aveva letto un libro che le era piaciuto e pensava sarebbe piaciuto anche a me, compatibilmente con la mia età e la mia esperienza man mano che crescevo, me lo passava senza dirmi a che genere apparteneva. Mi diceva solo: “questo mi è piaciuto. Leggilo anche tu e dimmi cosa ne pensi”. Per cui ho letto romanzi gialli: i classici “Gialli Mondadori”, con lo stesso spirito con cui leggevo le altre cose che lei mi passava. Mi sono accorto, dopo un po’, che le storie che più mi piacevano erano storie che avevano a che fare con il mistero, e che non mi venivano raccontate subito, ma piano piano, che è poi la tecnica del romanzo “giallo”. A quel punto, dopo un po’, ho iniziato a leggere soprattutto romanzi gialli. Poi ho incontrato “letterariamente” alcuni autori, uno di questi è stato Giorgio Scerbanenco, e mi è piaciuto quel modo di raccontare le cose, con uno strano personaggio pieno di contraddizioni, storie che mettevano in
ogni genere, e ogni volta che aveva letto un libro che le era piaciuto e pensava sarebbe piaciuto anche a me, compatibilmente con la mia età e la mia esperienza man mano che crescevo, me lo passava senza dirmi a che genere apparteneva. Mi diceva solo: “questo mi è piaciuto. Leggilo anche tu e dimmi cosa ne pensi”. Per cui ho letto romanzi gialli: i classici “Gialli Mondadori”, con lo stesso spirito con cui leggevo le altre cose che lei mi passava. Mi sono accorto, dopo un po’, che le storie che più mi piacevano erano storie che avevano a che fare con il mistero, e che non mi venivano raccontate subito, ma piano piano, che è poi la tecnica del romanzo “giallo”. A quel punto, dopo un po’, ho iniziato a leggere soprattutto romanzi gialli. Poi ho incontrato “letterariamente” alcuni autori, uno di questi è stato Giorgio Scerbanenco, e mi è piaciuto quel modo di raccontare le cose, con uno strano personaggio pieno di contraddizioni, storie che mettevano in  scena dei meccanismi che erano quelli che riconoscevo nella realtà, storie scritte con uno stile che non necessariamente doveva essere corretto, come l’italiano che mi insegnavano a scuola, ma anzi: che raccontava le cose con quelle parole che la professoressa a scuola mi avrebbe segnato con la matita rossa. A quel punto, quando mi è venuta in mente una cosa da scrivere, una bella idea, secondo me, ho cominciato a scriverla, ed è stata istintivamente un romanzo giallo. Avevo avuto un’idea che era buona per un romanzo storico, volevo raccontare di un poliziotto alla caduta di un regime, e quindi gli ultimi giorni della Repubblica di Salò, un poliziotto coinvolto in alcune situazioni. Però, visto che già stavo scrivendo la storia di un poliziotto, in più avevo in mente quella tecnica del giallo, il libro è diventato istintivamente un romanzo “noir” che parlava di un delitto e che voleva raccontare anche tutto il resto. Questo è quello che è successo. Poi sono entrati scrittori come James Ellroy, che mi ha fatto scoprire che si può scrivere di cose ancora più “sporche”, Raymond Chandler, tanti italiani come Loriano Macchiavelli… E alla fine, quando si fa questa domanda a un autore come me, che si muove soprattutto all’interno del genere “noir”, io e tutti gli altri autori dovremmo rispondere che leggiamo anche tutti gli scrittori contemporanei, dovremmo cioè mettere come modelli tutti i nostri amici, perché siamo un tipo di scrittori che, considerandosi molto artigiani, si scambiano i “ferri del mestiere”. Parlo in continuazione con Eraldo Baldini, Simona Vinci, Giampiero Rigosi, Marcello Fois, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo… e ci scambiamo continuamente le idee, le informazioni, gli stimoli. Leggiamo i nostri libri. Quindi alla fine “copio” da tutti loro.
scena dei meccanismi che erano quelli che riconoscevo nella realtà, storie scritte con uno stile che non necessariamente doveva essere corretto, come l’italiano che mi insegnavano a scuola, ma anzi: che raccontava le cose con quelle parole che la professoressa a scuola mi avrebbe segnato con la matita rossa. A quel punto, quando mi è venuta in mente una cosa da scrivere, una bella idea, secondo me, ho cominciato a scriverla, ed è stata istintivamente un romanzo giallo. Avevo avuto un’idea che era buona per un romanzo storico, volevo raccontare di un poliziotto alla caduta di un regime, e quindi gli ultimi giorni della Repubblica di Salò, un poliziotto coinvolto in alcune situazioni. Però, visto che già stavo scrivendo la storia di un poliziotto, in più avevo in mente quella tecnica del giallo, il libro è diventato istintivamente un romanzo “noir” che parlava di un delitto e che voleva raccontare anche tutto il resto. Questo è quello che è successo. Poi sono entrati scrittori come James Ellroy, che mi ha fatto scoprire che si può scrivere di cose ancora più “sporche”, Raymond Chandler, tanti italiani come Loriano Macchiavelli… E alla fine, quando si fa questa domanda a un autore come me, che si muove soprattutto all’interno del genere “noir”, io e tutti gli altri autori dovremmo rispondere che leggiamo anche tutti gli scrittori contemporanei, dovremmo cioè mettere come modelli tutti i nostri amici, perché siamo un tipo di scrittori che, considerandosi molto artigiani, si scambiano i “ferri del mestiere”. Parlo in continuazione con Eraldo Baldini, Simona Vinci, Giampiero Rigosi, Marcello Fois, Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo… e ci scambiamo continuamente le idee, le informazioni, gli stimoli. Leggiamo i nostri libri. Quindi alla fine “copio” da tutti loro.
Nel 1997 Esce per Einaudi Almost Blue, un grande successo letterario che può essere considerato una pietra miliare nella sua carriera di scrittore. Da questo libro è stato tratto un film (2000) diretto dal regista esordiente Alex Infascelli, e lì si è consolidata la sua avventura sul piccolo e grande schermo. Cosa ha significato per lei, e come lo schermo ha influenzato in seguito la sua attività di scrittore?
Almost blue è stata una cosa particolare. Alex Infascelli, che al tempo era al suo primo film, è stata sempre una persona moto geniale, ma anche un tipo esuberante. Mi aveva telefonato la prima volta dicendomi: “Complimenti, ho letto il tuo libro, mi è piaciuto molto e voglio farci un film. Lo sceneggiamo insieme, vengo a viere a casa tua e lo scriviamo!”. Va bene, gli dissi. Poi lo risento una seconda volta e mi dice: “Guarda nel frattempo ho già scritto la sceneggiatura. Te la mando e mi dici cosa ne pensi”. E io ho detto ancora una volta: “Ve bene”. Mi arriva la sceneggiatura e poi mi arriva anche la sua terza telefonata in cui mi dice: “Guarda, nel frattempo ho anche già fatto il film. Vieni a vederlo al cinema!”. E così sono andato a vederlo in anteprima e mi è piaciuto, ci mancherebbe, va benissimo. Ma è un film fatto da un’altra persona. E questa è una delle cose che ho imparato dall’inizio. Il regista è come se fosse un lettore, e il lettore ha il diritto di proiettarsi nella testa qualunque cosa trovi nelle tue parole, non puoi andargli a dire: “No, guarda è sbagliato, hai capito male!”. Semmai ti sei spiegato male tu. E quindi lui ha fatto un film che è soprattutto un film horror, incentrato sulla figura del serial killer. Mentre io, invece, avevo altre idee.
persona moto geniale, ma anche un tipo esuberante. Mi aveva telefonato la prima volta dicendomi: “Complimenti, ho letto il tuo libro, mi è piaciuto molto e voglio farci un film. Lo sceneggiamo insieme, vengo a viere a casa tua e lo scriviamo!”. Va bene, gli dissi. Poi lo risento una seconda volta e mi dice: “Guarda nel frattempo ho già scritto la sceneggiatura. Te la mando e mi dici cosa ne pensi”. E io ho detto ancora una volta: “Ve bene”. Mi arriva la sceneggiatura e poi mi arriva anche la sua terza telefonata in cui mi dice: “Guarda, nel frattempo ho anche già fatto il film. Vieni a vederlo al cinema!”. E così sono andato a vederlo in anteprima e mi è piaciuto, ci mancherebbe, va benissimo. Ma è un film fatto da un’altra persona. E questa è una delle cose che ho imparato dall’inizio. Il regista è come se fosse un lettore, e il lettore ha il diritto di proiettarsi nella testa qualunque cosa trovi nelle tue parole, non puoi andargli a dire: “No, guarda è sbagliato, hai capito male!”. Semmai ti sei spiegato male tu. E quindi lui ha fatto un film che è soprattutto un film horror, incentrato sulla figura del serial killer. Mentre io, invece, avevo altre idee.  Dopo, agli altri film che hanno fatto dai miei libri, tranne quelli sul Commissario De Luca, in qualche maniera ho sempre partecipato. Quindi li ho scritti io come sceneggiatore. Prima non sarei neanche stato in grado di farlo. E dunque sono film molto più vicini a quella che era la mia visione. Soprattutto per quanto riguarda l’Ispettore Coliandro. Lì a scrivere e a pensare la serie siamo stati Giampiero Rigosi ed io; siamo noi Coliandro. Poi arriva Giampaolo Morelli, attore, che diventa Coliandro, e poi i fratelli Manetti come registi. Ecco, tutta questa cosa ha influito fino a un certo punto sul mio modo di scrivere. Anche quando poi in televisione ci sono andato in prima persona a raccontare le cose, in realtà faccio sempre la stessa cosa che faccio nei romanzi: racconto cioè le cose in quel modo lì: c’è un mistero, ma non racconto tutto subito. Semmai ci sono delle piccole tecniche, nel cinema e nella televisione, che sono entrate nei miei romanzi dandomi una piccola mano a dire una cosa in un altro modo, in un modo sperimentale. Ma non c’è un travaso netto. Non ho cambiato il mio modo di scrivere. Anche se è vero, ad esempio, che non riesco più a scrivere romanzi con Coliandro come protagonista, perché nel frattempo Coliandro è diventato quel personaggio televisivo, tridimensionale, interpretato da Giampaolo Morelli. Non riesco più a pensarlo come lo pensavo prima: molto più cattivo, più amaro, più disperato.
Dopo, agli altri film che hanno fatto dai miei libri, tranne quelli sul Commissario De Luca, in qualche maniera ho sempre partecipato. Quindi li ho scritti io come sceneggiatore. Prima non sarei neanche stato in grado di farlo. E dunque sono film molto più vicini a quella che era la mia visione. Soprattutto per quanto riguarda l’Ispettore Coliandro. Lì a scrivere e a pensare la serie siamo stati Giampiero Rigosi ed io; siamo noi Coliandro. Poi arriva Giampaolo Morelli, attore, che diventa Coliandro, e poi i fratelli Manetti come registi. Ecco, tutta questa cosa ha influito fino a un certo punto sul mio modo di scrivere. Anche quando poi in televisione ci sono andato in prima persona a raccontare le cose, in realtà faccio sempre la stessa cosa che faccio nei romanzi: racconto cioè le cose in quel modo lì: c’è un mistero, ma non racconto tutto subito. Semmai ci sono delle piccole tecniche, nel cinema e nella televisione, che sono entrate nei miei romanzi dandomi una piccola mano a dire una cosa in un altro modo, in un modo sperimentale. Ma non c’è un travaso netto. Non ho cambiato il mio modo di scrivere. Anche se è vero, ad esempio, che non riesco più a scrivere romanzi con Coliandro come protagonista, perché nel frattempo Coliandro è diventato quel personaggio televisivo, tridimensionale, interpretato da Giampaolo Morelli. Non riesco più a pensarlo come lo pensavo prima: molto più cattivo, più amaro, più disperato.
Dal 1999 al 2009 ha condotto “Blu notte – Misteri italiani” (nella prima edizione si chiamava Mistero in Blu), programma in onda su Rai 3 che analizzava fatti di cronaca, indagini su omicidi e misteri della storia italiana. Per molti anni ha condotto trasmissioni televisive in cui ripercorreva celebri casi criminali esaminandone gli aspetti rimasti oscuri. Ci racconti qualcosa di questa esperienza.
Questa esperienza mi ha influenzato molto, anche se all’attività di scrittore ha aggiunto poco dal punto di vista  dello stile e del modo di raccontare. E questo perché sono stato io che ho preso il mio modo di raccontare e l’ho portato in televisione. Molte volte si parla di linguaggio televisivo, ma non so se esista veramente un linguaggio televisivo. Esistono delle possibilità che ti offre la televisione, e che magari in narrativa non avresti. La televisione ha come punto di forza il fatto che vedi delle cose, hai i documenti del passato. Posso mettermi a descrivere la Strage di Bologna o la Strage di Piazza Fontana con mille parole, mentre in televisione passa una fotografia, oppure un piccolo filmato di quel 2 agosto, e quello è! La strage di Piazza della Loggia a Brescia, in cui c’è la registrazione delle ultime parole dello speaker che sta parlando prima che scoppi la bomba; quelle io non posso riprodurle con le mie parole, non riesco a ricostruire quella cosa. Mando però il sonoro registrato ed è fatta, si rivive esattamente quell’emozione e quella sensazione di verità. Questo è il contributo che ha dato a me la televisione. Mentre il contributo che ho dato io alla televisione è un certo modo di raccontare le storie. Diciamo che ho imparato un metodo perché facendo prima “Mistero in blu”, che si occupava soprattutto di casi di cronaca, e poi “Blu notte”, che si occupava sempre di cronaca, ma con risvolti storici e politici, come le stragi e il terrorismo, la tecnica che abbiamo dovuto usare, non tanto per raccontare, ma per ricostruire i fatti, era proprio quella di studiare e documentarci. Che è quello che fanno sempre tutti i giornalisti e gli storici. La sfida è stata riuscire a mettere in scena i meccanismi di quello che raccontavamo, mettendo insieme le testimonianze di tutti. Ecco, questo rigore qui, questa tecnica, poi li ho portati nella letteratura. Il mio primo romanzo Carta bianca, era ambientato nel 1945, è vero che mi ero documentato per scriverlo, ma non ero entrato così tanto in quel momento storico. Cosa che invece ho fatto dopo nel romanzo L’inverno più nero, che è l’ultimo con il Commissario De Luca, dove si vede molto di più quel rigore che ho imparato facendo televisione.
dello stile e del modo di raccontare. E questo perché sono stato io che ho preso il mio modo di raccontare e l’ho portato in televisione. Molte volte si parla di linguaggio televisivo, ma non so se esista veramente un linguaggio televisivo. Esistono delle possibilità che ti offre la televisione, e che magari in narrativa non avresti. La televisione ha come punto di forza il fatto che vedi delle cose, hai i documenti del passato. Posso mettermi a descrivere la Strage di Bologna o la Strage di Piazza Fontana con mille parole, mentre in televisione passa una fotografia, oppure un piccolo filmato di quel 2 agosto, e quello è! La strage di Piazza della Loggia a Brescia, in cui c’è la registrazione delle ultime parole dello speaker che sta parlando prima che scoppi la bomba; quelle io non posso riprodurle con le mie parole, non riesco a ricostruire quella cosa. Mando però il sonoro registrato ed è fatta, si rivive esattamente quell’emozione e quella sensazione di verità. Questo è il contributo che ha dato a me la televisione. Mentre il contributo che ho dato io alla televisione è un certo modo di raccontare le storie. Diciamo che ho imparato un metodo perché facendo prima “Mistero in blu”, che si occupava soprattutto di casi di cronaca, e poi “Blu notte”, che si occupava sempre di cronaca, ma con risvolti storici e politici, come le stragi e il terrorismo, la tecnica che abbiamo dovuto usare, non tanto per raccontare, ma per ricostruire i fatti, era proprio quella di studiare e documentarci. Che è quello che fanno sempre tutti i giornalisti e gli storici. La sfida è stata riuscire a mettere in scena i meccanismi di quello che raccontavamo, mettendo insieme le testimonianze di tutti. Ecco, questo rigore qui, questa tecnica, poi li ho portati nella letteratura. Il mio primo romanzo Carta bianca, era ambientato nel 1945, è vero che mi ero documentato per scriverlo, ma non ero entrato così tanto in quel momento storico. Cosa che invece ho fatto dopo nel romanzo L’inverno più nero, che è l’ultimo con il Commissario De Luca, dove si vede molto di più quel rigore che ho imparato facendo televisione.
Per la televisione nel 2006 ha ideato la fiction L’ispettore Coliandro, di cui abbiamo già accennato. La serie, di grande successo, è stata diretta dai fratelli Manetti. Come nasce il personaggio di Coliandro, e come è nata la collaborazione con questi due registi, e soprattutto cosa ha significato per lei?
Il personaggio di Coliandro è nato prima in letteratura, in un piccolo racconto, anche se poi è diventato il  protagonista di altri due romanzi, ed è nato in una maniera strana. Avevo scritto i primi romanzi con il Commissario De Luca, quando ci siamo messi insieme con altri scrittori di romanzi gialli di Bologna per fondare il “Gruppo 13”. Eravamo in dodici, ma ci siamo chiamati “13” perché questo numero faceva più “noir” rispetto al dodici. Con il Gruppo 13 abbiamo fatto un’antologia di racconti. Poi Lorenzo Marzaduri, che è uno scrittore di “noir” contemporanei all’americana, autore di due bellissimi romanzi, molto d’azione, mi disse che voleva scrivere un racconto ambientato nel periodo fascista. Allora io dissi: “Ma come? Sono io quello scrive romanzi storici! Se è così, allora io scriverò un racconto ambientato ai giorni nostri in stile Ispettore Callaghan”. In quel periodo frequentavo un po’ le questure perché facevo il giornalista e mi occupavo di cronaca nera per un settimanale locale di Imola che usciva il sabato sera, e avevo raccolto un po’ di cose sulla polizia. E quindi ho pensato che avrei fatto un “Ispettore Callaghan” con tutti gli strani aneddoti che mi avevano raccontato i miei amici poliziotti. Quindi qualcosa anche di un po’ umoristico, ma intorno a un personaggio che nelle mie intenzioni era un personaggio molto negativo: un cattivo tenente all’italiana, maschilista, razzista ecc. Poi, però, mi è venuto in mente che non volevo che la gente pensasse che la pensavo anche io come il mio personaggio, un po’come Mickey Spillane. Quando leggi Spillane sai che il suo personaggio è proprio come lui. Allora ho pensato, riguardo al mio personaggio, che ogni volta che fa qualcosa che a me non piace, io “lo bastono”, facendogli fare una brutta figura. E quindi Coliandro è diventato un personaggio perdente e umoristico, perché la figuraccia che fa è una figuraccia divertente. Essendo però un personaggio onesto – altrimenti il romanzo sarebbe finito a pagina uno -, è diventato un onesto perdente, che per quanto negativo possa essere, in qualche
protagonista di altri due romanzi, ed è nato in una maniera strana. Avevo scritto i primi romanzi con il Commissario De Luca, quando ci siamo messi insieme con altri scrittori di romanzi gialli di Bologna per fondare il “Gruppo 13”. Eravamo in dodici, ma ci siamo chiamati “13” perché questo numero faceva più “noir” rispetto al dodici. Con il Gruppo 13 abbiamo fatto un’antologia di racconti. Poi Lorenzo Marzaduri, che è uno scrittore di “noir” contemporanei all’americana, autore di due bellissimi romanzi, molto d’azione, mi disse che voleva scrivere un racconto ambientato nel periodo fascista. Allora io dissi: “Ma come? Sono io quello scrive romanzi storici! Se è così, allora io scriverò un racconto ambientato ai giorni nostri in stile Ispettore Callaghan”. In quel periodo frequentavo un po’ le questure perché facevo il giornalista e mi occupavo di cronaca nera per un settimanale locale di Imola che usciva il sabato sera, e avevo raccolto un po’ di cose sulla polizia. E quindi ho pensato che avrei fatto un “Ispettore Callaghan” con tutti gli strani aneddoti che mi avevano raccontato i miei amici poliziotti. Quindi qualcosa anche di un po’ umoristico, ma intorno a un personaggio che nelle mie intenzioni era un personaggio molto negativo: un cattivo tenente all’italiana, maschilista, razzista ecc. Poi, però, mi è venuto in mente che non volevo che la gente pensasse che la pensavo anche io come il mio personaggio, un po’come Mickey Spillane. Quando leggi Spillane sai che il suo personaggio è proprio come lui. Allora ho pensato, riguardo al mio personaggio, che ogni volta che fa qualcosa che a me non piace, io “lo bastono”, facendogli fare una brutta figura. E quindi Coliandro è diventato un personaggio perdente e umoristico, perché la figuraccia che fa è una figuraccia divertente. Essendo però un personaggio onesto – altrimenti il romanzo sarebbe finito a pagina uno -, è diventato un onesto perdente, che per quanto negativo possa essere, in qualche 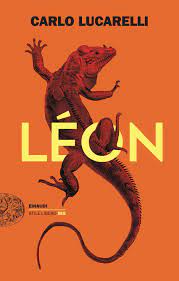 maniera comunque una qualche empatia e tenerezza le suscita, e alla fine capisci che il personaggio è meglio di quello che sembra. E così ho scritto le prime tre cose con Coliandro come protagonista. Poi è arrivata la televisione, con un produttore legato alla RAI che ha detto quello che dicevano una volta i produttori: “Bellissimo il tuo libro, fantastico, originale, non si è mai visto un personaggio così: uno che non sa fare il suo mestiere, che dice un sacco di parolacce, che è razzista, che ha tutte le cose negative… meraviglioso! Vorremmo farne un film, ma dovresti cambiare un po’ il tuo personaggio in modo che non dica parolacce, sia bravissimo a fare il poliziotto e non sia così negativo, perché, sai, in TV non si può”. Ok, allora non comprate il mio libro, facciamo un altro personaggio, ho risposto io. Abbiamo lottato quattro anni, Giampiero Rigosi ed io, e alla fine siamo riusciti a fare quello che volevamo noi, come sceneggiatura. Poi però il progetto si era fermato, ma nel frattempo sono arrivati i Fratelli Manetti che avevano delle idee ben precise su come fare questo film, e cioè molto fumettistico, un po’anni sessanta, molto poliziottesco… e quindi ci siamo capiti e trovati subito. I Manetti hanno proposto Giampaolo Morelli come attore, che io non conoscevo. Appena l’ho visto, Morelli mi ha dato la mano storta, così come fanno la maggior parte di quelli delle forze dell’ordine che io conosco, un modo molto militare. E così mi sono detto “Eccolo qua, è lui l’attore giusto per Coliandro!”. E così abbiamo cominciato insieme a costruire questa cosa. Noi scrivevamo, Morelli interiorizzava Coliandro, diventava Coliandro e i Manetti diventavano il suo sguardo. Allora abbiamo cominciato a scrivere film uno dietro l’altro per la televisione, ma io ho smesso di scrivere romanzi con Coliandro perché, nel frattempo, questo personaggio era diventato un’altra cosa. Non mi è dispiaciuto, però era diverso dal Coliandro dei miei romanzi che, invece, è rimasto lì. Vedi, noi abbiamo un mantra, perché Coliandro è riuscito ad incontrare il favore del pubblico, anche di gente che mai e poi mai starebbero con lui nella realtà. E così noi diciamo che: Montalbano ha dei fan – e io sono uno di questi -. Il Commissario Schiavone ha dei fan – e anche io sono uno di questi -. Don Matteo ha dei fan – e anche io potrei essere uno di questi -, ma Coliandro ha degli ultrà. Ha degli hooligan! Come allo stadio. E questo ci fa molto piacere.
maniera comunque una qualche empatia e tenerezza le suscita, e alla fine capisci che il personaggio è meglio di quello che sembra. E così ho scritto le prime tre cose con Coliandro come protagonista. Poi è arrivata la televisione, con un produttore legato alla RAI che ha detto quello che dicevano una volta i produttori: “Bellissimo il tuo libro, fantastico, originale, non si è mai visto un personaggio così: uno che non sa fare il suo mestiere, che dice un sacco di parolacce, che è razzista, che ha tutte le cose negative… meraviglioso! Vorremmo farne un film, ma dovresti cambiare un po’ il tuo personaggio in modo che non dica parolacce, sia bravissimo a fare il poliziotto e non sia così negativo, perché, sai, in TV non si può”. Ok, allora non comprate il mio libro, facciamo un altro personaggio, ho risposto io. Abbiamo lottato quattro anni, Giampiero Rigosi ed io, e alla fine siamo riusciti a fare quello che volevamo noi, come sceneggiatura. Poi però il progetto si era fermato, ma nel frattempo sono arrivati i Fratelli Manetti che avevano delle idee ben precise su come fare questo film, e cioè molto fumettistico, un po’anni sessanta, molto poliziottesco… e quindi ci siamo capiti e trovati subito. I Manetti hanno proposto Giampaolo Morelli come attore, che io non conoscevo. Appena l’ho visto, Morelli mi ha dato la mano storta, così come fanno la maggior parte di quelli delle forze dell’ordine che io conosco, un modo molto militare. E così mi sono detto “Eccolo qua, è lui l’attore giusto per Coliandro!”. E così abbiamo cominciato insieme a costruire questa cosa. Noi scrivevamo, Morelli interiorizzava Coliandro, diventava Coliandro e i Manetti diventavano il suo sguardo. Allora abbiamo cominciato a scrivere film uno dietro l’altro per la televisione, ma io ho smesso di scrivere romanzi con Coliandro perché, nel frattempo, questo personaggio era diventato un’altra cosa. Non mi è dispiaciuto, però era diverso dal Coliandro dei miei romanzi che, invece, è rimasto lì. Vedi, noi abbiamo un mantra, perché Coliandro è riuscito ad incontrare il favore del pubblico, anche di gente che mai e poi mai starebbero con lui nella realtà. E così noi diciamo che: Montalbano ha dei fan – e io sono uno di questi -. Il Commissario Schiavone ha dei fan – e anche io sono uno di questi -. Don Matteo ha dei fan – e anche io potrei essere uno di questi -, ma Coliandro ha degli ultrà. Ha degli hooligan! Come allo stadio. E questo ci fa molto piacere.
Tornando alla scrittura: Viene molto apprezzata dai lettori e dai critici la sua capacità di mescolare sapientemente generi diversi tra loro. Inoltre lei insegna scrittura alla Scuola Holden di Alessandro Baricco a Torino, nel carcere “Due Palazzi” di Padova e non solo. Nel 2010 ha addirittura fondato insieme a Giampiero Rigosi, Michele Cogo e a Beatrice Renzi la scuola di scrittura “Bottega Finzioni” a Bologna. Rivolgendosi a scrittori giovani ed esordienti, quale è la “ricetta”, secondo lei, per scrivere un buon giallo e un romanzo coinvolgente?
Ci abbiamo pensato molte volte a questa cosa e l’abbiamo studiata. Io appartengo a quella generazione di  scrittori che non ha mai fatto scuole di scrittura, soprattutto perché al tempo non ce n’erano, altrimenti l’avrei fatta volentieri. Le scuole di scrittura si dividono in due categorie: la scuola di scrittura vera e propria, l’università della scrittura che fa lezioni e che ti insegna a scrivere, e poi il laboratorio di scrittura. La Bottega Finzioni, di cui da un po’ non faccio più parte, aveva questa filosofia: quella cioè del laboratorio. Così come accadeva nelle botteghe degli antichi pittori, dove i giovani allievi lavoravano insieme al maestro che aveva già risolto certi problemi perché ci aveva lavorato tanti anni, e imparando portavano al tempo stesso anche il loro contributo. Questo si può fare soprattutto con la letteratura di genere, non perché noi, scrittori di genere, abbiamo una grammatica così precisa – come dicevano i giallisti di una volta, in cui a pagina 2 ci vuole quello, e a pagina 12 quell’altro… -, non è mai stato così. Ma perché abbiamo a che fare con una grammatica del racconto che, in effetti, noi abbiamo già affrontato e risolto. Ci sono alcune cose tecniche, come la suspense quando leggi un certo racconto e ti batte il cuore, e rimani lì attaccato per vedere cosa succede, e hai paura che succeda qualcosa. Come ci si arriva lì? Nel cinema molte volte basta alzare la musica, ma in letteratura come
scrittori che non ha mai fatto scuole di scrittura, soprattutto perché al tempo non ce n’erano, altrimenti l’avrei fatta volentieri. Le scuole di scrittura si dividono in due categorie: la scuola di scrittura vera e propria, l’università della scrittura che fa lezioni e che ti insegna a scrivere, e poi il laboratorio di scrittura. La Bottega Finzioni, di cui da un po’ non faccio più parte, aveva questa filosofia: quella cioè del laboratorio. Così come accadeva nelle botteghe degli antichi pittori, dove i giovani allievi lavoravano insieme al maestro che aveva già risolto certi problemi perché ci aveva lavorato tanti anni, e imparando portavano al tempo stesso anche il loro contributo. Questo si può fare soprattutto con la letteratura di genere, non perché noi, scrittori di genere, abbiamo una grammatica così precisa – come dicevano i giallisti di una volta, in cui a pagina 2 ci vuole quello, e a pagina 12 quell’altro… -, non è mai stato così. Ma perché abbiamo a che fare con una grammatica del racconto che, in effetti, noi abbiamo già affrontato e risolto. Ci sono alcune cose tecniche, come la suspense quando leggi un certo racconto e ti batte il cuore, e rimani lì attaccato per vedere cosa succede, e hai paura che succeda qualcosa. Come ci si arriva lì? Nel cinema molte volte basta alzare la musica, ma in letteratura come  fai? Ecco, questa cosa qui molti autori l’hanno già fatta, noi la studiamo e quindi si può fare. Poi, cosa si dovrebbe dire ai giovani e aspiranti scrittori? Sicuramente che ci sono tre cose importanti. La prima è leggere, perché si impara a scrivere leggendo altri libri. La seconda è scrivere! Perché è incredibile come molti giovani aspiranti scrittori, non scrivano quasi niente. Scrivere è una palestra, è capire come si fanno certe cose. Non è che basta aver scritto un romanzo a diciotto anni e a quel punto sei uno scrittore. Oppure pensare che scriverai un romanzo bellissimo, ma ancora non hai scritto niente. E la terza cosa è farsi leggere, avere cioè delle persone che ti leggono e ti dicono sinceramente cosa pensano: se si sono annoiate, se gli è piaciuto ecc. Poi, come si fa a scrivere un buon giallo? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto corsi di scrittura, laboratori, ma se vogliamo ridurlo in poche parole, dovremmo dire che per fare un buon “noir” bisogno costruire un “mistero misterioso”, che sia coinvolgente, inquietante, irrisolto e imperdonabile. Non posso cioè perdonare a quel mistero di esistere! La mia vita di lettore non va avanti se non svelo questo mistero. E questo mistero deve essere svelato poco per volta. Il resto sono piccoli dettagli: suspense, colpi di scena, ritmo giusto ecc. Un “mistero misterioso”. Ricordo che una volta, in occasione del “Premio Gran Giallo città di Cattolica”, premiammo il racconto di una giovane scrittrice in cui era sparito un portafogli. Che uno dice: “ma chissenefrega, non c’è niente di strano, è sparito un portafoglio, succede a tante persone…”. Sì, ma nel racconto, lei non sapeva se quel portafoglio gli era stato rubato dalla persona della quale lei si era appena innamorata. Ed ecco, allora, che quel portafoglio diventa un mistero enorme! E lei non lo ha svelato subito questo mistero, ha cominciato a raccontarlo un po’ alla volta. Ecco, questo è un giallo!
fai? Ecco, questa cosa qui molti autori l’hanno già fatta, noi la studiamo e quindi si può fare. Poi, cosa si dovrebbe dire ai giovani e aspiranti scrittori? Sicuramente che ci sono tre cose importanti. La prima è leggere, perché si impara a scrivere leggendo altri libri. La seconda è scrivere! Perché è incredibile come molti giovani aspiranti scrittori, non scrivano quasi niente. Scrivere è una palestra, è capire come si fanno certe cose. Non è che basta aver scritto un romanzo a diciotto anni e a quel punto sei uno scrittore. Oppure pensare che scriverai un romanzo bellissimo, ma ancora non hai scritto niente. E la terza cosa è farsi leggere, avere cioè delle persone che ti leggono e ti dicono sinceramente cosa pensano: se si sono annoiate, se gli è piaciuto ecc. Poi, come si fa a scrivere un buon giallo? Per rispondere a questa domanda abbiamo fatto corsi di scrittura, laboratori, ma se vogliamo ridurlo in poche parole, dovremmo dire che per fare un buon “noir” bisogno costruire un “mistero misterioso”, che sia coinvolgente, inquietante, irrisolto e imperdonabile. Non posso cioè perdonare a quel mistero di esistere! La mia vita di lettore non va avanti se non svelo questo mistero. E questo mistero deve essere svelato poco per volta. Il resto sono piccoli dettagli: suspense, colpi di scena, ritmo giusto ecc. Un “mistero misterioso”. Ricordo che una volta, in occasione del “Premio Gran Giallo città di Cattolica”, premiammo il racconto di una giovane scrittrice in cui era sparito un portafogli. Che uno dice: “ma chissenefrega, non c’è niente di strano, è sparito un portafoglio, succede a tante persone…”. Sì, ma nel racconto, lei non sapeva se quel portafoglio gli era stato rubato dalla persona della quale lei si era appena innamorata. Ed ecco, allora, che quel portafoglio diventa un mistero enorme! E lei non lo ha svelato subito questo mistero, ha cominciato a raccontarlo un po’ alla volta. Ecco, questo è un giallo!
Negli ultimi anni vanno molto di moda i gialli scandinavi, da Nesbo, a Kepler a Kamilla Lackberg, come giudica questo fenomeno e cosa distingue questo filone del Nord dal giallo italiano?
Non ci sono grandi differenze, e forse è per questo che questi gialli ci piacciono molto. Il giallo scandinavo ha un rigore di scrittura, di presentazione dei personaggi che magari è diverso dai nostri gialli. Da un certo punto di vista possiamo dire che c’è meno sentimento, meno lirismo, meno romanticismo del cosiddetto “giallo mediterraneo” che sarebbe quello italiano, fino alla Germania. Però le molle che ci hanno fatto amare il giallo scandinavo sono innanzitutto il fatto che ci troviamo di fronte a delle belle storie, scritte da scrittori bravi. Poi è anche vero che una volta che la moda si è affermata viene pubblicato chiunque. Basta che il cognome di uno scrittore finisca in “sson” o in “ddur”, e anche se è nato a Brisighella, in provincia di Ravenna, va bene uguale, lo pubblicano. È un giallo scandinavo! Però la verità è che la fortuna del giallo scandinavo è dovuta prima di tutto a grandi scrittori. Poi anche al fatto della sorpresa di trovare storie così in posti in cui non te lo saresti mai aspettato. Nel nostro immaginario la Scandinavia è un posto meraviglioso, dove non succede mai niente. Cosa arriva dalla Scandinavia? Babbo Natale e basta! La stessa cosa si diceva anche dell’Italia. Si diceva che in Italia non puoi scrivere un romanzo giallo, ci sono “pizza, sole e mandolino…” E invece no: Mafia, corruzione, stragi… e tutto quello che la nostra storia si porta dietro. Anche da loro, in Scandinavia, sono successe cose incredibili. Soprattutto in Svezia. E quindi ti stupisce qualcosa di credibile avvenuto nel paese di Babbo Natale, e raccontato bene. Secondo me questa è stata una molla molto importante. Ricordo che una volta guardavo una serie ambientata a Helsinki, in cui un commissario di polizia lasciava la città per andarsene in un paesino sperduto, perché diceva che ogni strada di Helsinki gli ricordava il sangue di un omicidio. Poi, però, vai a vedere le statistiche criminali e scopri che a Helsinki ci sono quattro omicidi all’anno! Eppure la serie è credibilissima, perché se dici che ogni angolo ti ricorda il sangue, questo appartiene a un immaginario collettivo che abbiamo tutti.
rigore di scrittura, di presentazione dei personaggi che magari è diverso dai nostri gialli. Da un certo punto di vista possiamo dire che c’è meno sentimento, meno lirismo, meno romanticismo del cosiddetto “giallo mediterraneo” che sarebbe quello italiano, fino alla Germania. Però le molle che ci hanno fatto amare il giallo scandinavo sono innanzitutto il fatto che ci troviamo di fronte a delle belle storie, scritte da scrittori bravi. Poi è anche vero che una volta che la moda si è affermata viene pubblicato chiunque. Basta che il cognome di uno scrittore finisca in “sson” o in “ddur”, e anche se è nato a Brisighella, in provincia di Ravenna, va bene uguale, lo pubblicano. È un giallo scandinavo! Però la verità è che la fortuna del giallo scandinavo è dovuta prima di tutto a grandi scrittori. Poi anche al fatto della sorpresa di trovare storie così in posti in cui non te lo saresti mai aspettato. Nel nostro immaginario la Scandinavia è un posto meraviglioso, dove non succede mai niente. Cosa arriva dalla Scandinavia? Babbo Natale e basta! La stessa cosa si diceva anche dell’Italia. Si diceva che in Italia non puoi scrivere un romanzo giallo, ci sono “pizza, sole e mandolino…” E invece no: Mafia, corruzione, stragi… e tutto quello che la nostra storia si porta dietro. Anche da loro, in Scandinavia, sono successe cose incredibili. Soprattutto in Svezia. E quindi ti stupisce qualcosa di credibile avvenuto nel paese di Babbo Natale, e raccontato bene. Secondo me questa è stata una molla molto importante. Ricordo che una volta guardavo una serie ambientata a Helsinki, in cui un commissario di polizia lasciava la città per andarsene in un paesino sperduto, perché diceva che ogni strada di Helsinki gli ricordava il sangue di un omicidio. Poi, però, vai a vedere le statistiche criminali e scopri che a Helsinki ci sono quattro omicidi all’anno! Eppure la serie è credibilissima, perché se dici che ogni angolo ti ricorda il sangue, questo appartiene a un immaginario collettivo che abbiamo tutti.
Per il teatro lei ha scritto, oltre a Via delle Oche, Tenco a tempo di tango, e Pasolini un mistero italiano. Quest’anno ricorre l’anniversario della nascita di Pasolini, che idea si è fatto personalmente della vicenda, e del “giallo” di questo grande intellettuale italiano?
Quando si parla della morte di Pasolini il fronte si spacca subito in due, e addirittura si litiga. Da una parte c’è la versione che ci ha dato la verità processuale, e cioè che Pasolini rimorchia Pelosi, gli chiede cose che Pelosi non vuole, diventa violento, Pelosi reagisce, e succede quello che succede. Fine. Questa è la verità giudiziaria.
 Non credo che sia andata così, anzi, ne sono abbastanza certo che non sia andata così. E questo per via di alcune risultanze scientifiche: l’autopsia che è stata fatta, il sopralluogo dove è avvenuto il delitto fatto dopo da Franco Citti e altri… Insomma, tante evidenze scientifiche fanno pensare che Pasolini sia stato ammazzato da molte più persone. Ci sono poi testimonianze che parlano di un appuntamento di Pasolini, il fatto che Pasolini conoscesse Pelosi da prima ancora… tantissime cose che abbiamo scoperto dopo fanno pensare che Pasolini sia stato ucciso da più persone in un agguato studiato non da Pino Pelosi, ma da più persone che gli avevano dato un appuntamento preciso. Fino a qui credo di esserne ragionevolmente certo. La domanda è: perché un po’ di gente dà un appuntamento in un posto a Pasolini e poi lo ammazza? E secondo me la risposta è sempre e comunque politica. Bisogna tornare nel contesto di quegli anni.
Non credo che sia andata così, anzi, ne sono abbastanza certo che non sia andata così. E questo per via di alcune risultanze scientifiche: l’autopsia che è stata fatta, il sopralluogo dove è avvenuto il delitto fatto dopo da Franco Citti e altri… Insomma, tante evidenze scientifiche fanno pensare che Pasolini sia stato ammazzato da molte più persone. Ci sono poi testimonianze che parlano di un appuntamento di Pasolini, il fatto che Pasolini conoscesse Pelosi da prima ancora… tantissime cose che abbiamo scoperto dopo fanno pensare che Pasolini sia stato ucciso da più persone in un agguato studiato non da Pino Pelosi, ma da più persone che gli avevano dato un appuntamento preciso. Fino a qui credo di esserne ragionevolmente certo. La domanda è: perché un po’ di gente dà un appuntamento in un posto a Pasolini e poi lo ammazza? E secondo me la risposta è sempre e comunque politica. Bisogna tornare nel contesto di quegli anni.
Nel 1975 ci sono sei omicidi di questo tipo. C’è la morte di Alberto Brasili, un ragazzo che attraversa per sbaglio un quartiere di destra, e viene ammazzato perché è vestito “da sinistra”. C’è la morte di Sergio Ramelli, che è un ragazzo di estrema destra che viene ammazzato a sprangate da gente di estrema sinistra. C’è la vicenda, poco dopo, di Franca Rame che viene rapita e violentata per la sua attività politica di sinistra. Esiste in quegli anni un odio per “chi non è come te”, ma anzi rappresenta un’altra parte, che porta ad uccidere. L’avversario politico veniva ammazzato. Pasolini è stato ucciso perché era “frocio” e comunista. Poi, però, possiamo andare un pochino più in là e pensare che forse è stato ucciso per quello che stava scrivendo: Petrolio. Pasolini non era un intellettuale astratto, come molte volte viene dipinto, ma conosceva invece molto bene i meccanismi della società italiana, della “strategia della tensione”, e sapeva tante cose. Pasolini si scriveva con Giovanni Ventura, prima che finisse in galera, quando Ventura era uno dei sospettati della Strage di Piazza Fontana. Ed era così bravo da dirgli: “Stai attento alle balle che mi stai raccontando, perché se continui a raccontarmele, io non ti ascolto più”. Era cioè uno in grado di capire. Quello di Pasolini rimane sempre un delitto politico, ma con una motivazione più complessa. E comunque Pelosi non c’entra in questa storia.
È già in corso l’edizione 2022 del Premio Strega. Nonostante lei di premi ne abbia vinti tanti, sappiamo che il romanzo di genere stenta a entrare in alcuni premi letterari italiani; come se lo spiega?
Sì, è vero. Noi una volta eravamo nel “ghetto”. Ora non ci siamo più e, anzi, siamo addirittura di moda, ci mancherebbe! Però rimane sempre un po’ questo pregiudizio nei confronti del giallo, anche se non si chiama più così, ma lo chiamiamo “noir”, forse tra un po’ cambierà di nuovo nome. Vedi, oggi tanta gente ti dice: “io non leggo noir”, ma nessuno lo direbbe di altre cose come: “no, io non leggo romanzi italiani”, oppure: “no, io non leggo Baricco, o Veronesi…” Nessuno ti direbbe questo. Però puoi dire: “non leggo noir”. Questo pregiudizio comunque esiste. Ce ne siamo resi conto quando abbiamo iniziato a scalfirlo, quando poco a poco il “noir” è uscito dal ghetto. Con tutte le mille giustificazioni che avevano i critici – che invece adesso ci recensiscono senza problemi – per non parlare di noi. Negli anni Novanta, ogni volta che un critico presentava uno scrittore come me, si portava dietro una pila di libri molto alta, e faceva per venti minuti la storia del giallo italiano, per far vedere che il giallo era un genere letterario di tutto rispetto, quasi a doversi giustificare del fatto che stava parlando di un giallista. Ora non è più così, ma qualche piccolo pregiudizio rimane. Se guardiamo al Premio Strega, sono stati premiati autori che hanno scritto romanzi “noir”, come Veronesi, Lagioia… Ma non sono autori di “noir”. Sono autori “mainstream” che hanno scritto anche “noir”. Ma piano, piano ci stiamo entrando anche lì. Ci sta magari che premiano Carofiglio, che tempo fa era uno dei principali candidati, che è un giallista – non solo- che ha scritto un romanzo giallo. Io non lo so, perché scrivo cose più particolari e sono molto connotato da quel punto di vista. Devo dire che il Premio Strega è bellissimo, ma a me non cambia molto.
leggo Baricco, o Veronesi…” Nessuno ti direbbe questo. Però puoi dire: “non leggo noir”. Questo pregiudizio comunque esiste. Ce ne siamo resi conto quando abbiamo iniziato a scalfirlo, quando poco a poco il “noir” è uscito dal ghetto. Con tutte le mille giustificazioni che avevano i critici – che invece adesso ci recensiscono senza problemi – per non parlare di noi. Negli anni Novanta, ogni volta che un critico presentava uno scrittore come me, si portava dietro una pila di libri molto alta, e faceva per venti minuti la storia del giallo italiano, per far vedere che il giallo era un genere letterario di tutto rispetto, quasi a doversi giustificare del fatto che stava parlando di un giallista. Ora non è più così, ma qualche piccolo pregiudizio rimane. Se guardiamo al Premio Strega, sono stati premiati autori che hanno scritto romanzi “noir”, come Veronesi, Lagioia… Ma non sono autori di “noir”. Sono autori “mainstream” che hanno scritto anche “noir”. Ma piano, piano ci stiamo entrando anche lì. Ci sta magari che premiano Carofiglio, che tempo fa era uno dei principali candidati, che è un giallista – non solo- che ha scritto un romanzo giallo. Io non lo so, perché scrivo cose più particolari e sono molto connotato da quel punto di vista. Devo dire che il Premio Strega è bellissimo, ma a me non cambia molto.
I suoi romanzi sono stati tradotti in diverse lingue, tra le quali il francese. Alcuni sono usciti nella prestigiosa Série noir della Gallimard. Che rapporto ha con i traduttori; segue personalmente le traduzioni o lascia loro completamente campo libero?
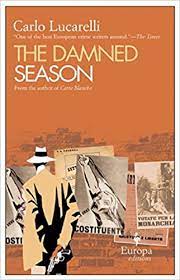 Per un lungo periodo ho avuto un rapporto molto stretto con i traduttori, soprattutto in Francia e in Germania. I traduttori mi chiamavano, interagivamo, ci parlavamo e ci chiedevamo delle cose. Quando sono andato a presentare i miei libri, molto spesso l’ho fatto insieme a loro. La stessa cosa è successa negli USA e in Inghilterra, per un po’ di tempo. Adesso però non avviene più. Magari ormai mi conoscono così bene che non hanno più bisogno di chiedermi delle cose. Dunque non ho più un rapporto così stretto con i miei traduttori, ma so che, invece, è un rapporto che dovrebbe essere sempre strettissimo, perché la traduzione è importantissima. Ogni tanto incontro qualcuno che mi dice che ha letto un autore che a me è piaciuto molto, solo che lui l’ha letto in un’altra lingua e non gli è piaciuto. Magari io lo leggo in italiano, lui in olandese e la lingua dell’autore è il cinese. Questo dimostra quanto sia importante la traduzione. E anche quanto siano importanti certe piccole censure del traduttore che deve adattare quello che si scrive alla capacità di comprensione di un lettore straniero. Faccio un esempio: il mio personaggio di Lèon e di Almost Blue si chiama Grazia Negro. Negli USA si è chiamata Grazie Neri; ma non me lo hanno neanche chiesto. Se me lo avessero chiesto, magari avrei inventato un cognome più adatto a lei. Il cognome “Negro” era impensabile in un certo contesto, come gli USA. E sono d’accordo. Quindi quello con i traduttori è un rapporto che dovrei curare di più. Molto di più.
Per un lungo periodo ho avuto un rapporto molto stretto con i traduttori, soprattutto in Francia e in Germania. I traduttori mi chiamavano, interagivamo, ci parlavamo e ci chiedevamo delle cose. Quando sono andato a presentare i miei libri, molto spesso l’ho fatto insieme a loro. La stessa cosa è successa negli USA e in Inghilterra, per un po’ di tempo. Adesso però non avviene più. Magari ormai mi conoscono così bene che non hanno più bisogno di chiedermi delle cose. Dunque non ho più un rapporto così stretto con i miei traduttori, ma so che, invece, è un rapporto che dovrebbe essere sempre strettissimo, perché la traduzione è importantissima. Ogni tanto incontro qualcuno che mi dice che ha letto un autore che a me è piaciuto molto, solo che lui l’ha letto in un’altra lingua e non gli è piaciuto. Magari io lo leggo in italiano, lui in olandese e la lingua dell’autore è il cinese. Questo dimostra quanto sia importante la traduzione. E anche quanto siano importanti certe piccole censure del traduttore che deve adattare quello che si scrive alla capacità di comprensione di un lettore straniero. Faccio un esempio: il mio personaggio di Lèon e di Almost Blue si chiama Grazia Negro. Negli USA si è chiamata Grazie Neri; ma non me lo hanno neanche chiesto. Se me lo avessero chiesto, magari avrei inventato un cognome più adatto a lei. Il cognome “Negro” era impensabile in un certo contesto, come gli USA. E sono d’accordo. Quindi quello con i traduttori è un rapporto che dovrei curare di più. Molto di più.
Lei è un discendente dell’inventore italiano Antonio Meucci, e dunque non poteva non interessarsi in qualche modo di “comunicazione”, ci vuole raccontare questa parentela?
 Mia nonna era una Meucci e dall’albero genealogico che ha ricostruito mio fratello, risulta che Antonio Meucci era il cugino del mio Bisnonno. Io me ne vanto perché Meucci è un personaggio grandioso: molto italiano, un geniale disorganizzato. Perché se fosse stato così geniale in un paese come gli Stati Uniti sarebbe stato pieno di soldi. E, invece, poverino… Ma Meucci non è solo quello che ha inventato il telefono. Meucci è stato un rivoluzionario, ha inventato macchine per i teatri in Brasile, ne ha fatte di tutti i colori! Era amico di Garibaldi… insomma, un personaggio da farci un film, anzi, una serie televisiva molto bella e complessa. E insieme a tutto questo ha inventato anche il telefono. Ci sono i miei parenti Meucci che tutte le volte che li incontro stanno ancora a calcolare quanti soldi avrebbero oggi se gli avessero riconosciuto i diritti per l’invenzione del telefono. Almeno fino all’invenzione del telefono cellulare, avrebbero avuto davvero un sacco di soldi.
Mia nonna era una Meucci e dall’albero genealogico che ha ricostruito mio fratello, risulta che Antonio Meucci era il cugino del mio Bisnonno. Io me ne vanto perché Meucci è un personaggio grandioso: molto italiano, un geniale disorganizzato. Perché se fosse stato così geniale in un paese come gli Stati Uniti sarebbe stato pieno di soldi. E, invece, poverino… Ma Meucci non è solo quello che ha inventato il telefono. Meucci è stato un rivoluzionario, ha inventato macchine per i teatri in Brasile, ne ha fatte di tutti i colori! Era amico di Garibaldi… insomma, un personaggio da farci un film, anzi, una serie televisiva molto bella e complessa. E insieme a tutto questo ha inventato anche il telefono. Ci sono i miei parenti Meucci che tutte le volte che li incontro stanno ancora a calcolare quanti soldi avrebbero oggi se gli avessero riconosciuto i diritti per l’invenzione del telefono. Almeno fino all’invenzione del telefono cellulare, avrebbero avuto davvero un sacco di soldi.




