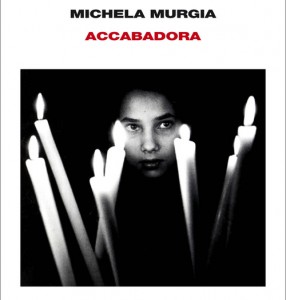La scrittrice Michela Murgia è stata protagonista a Praga, tra il 9 e il 10 giugno scorsi, di una serie di eventi culturali organizzati in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, il Comitato praghese della Società Dante Alighieri, il Ristorante “Bisos” e la Casa Editrice “Paseka”. La scrittrice sarda, nota anche per il suo impegno politico oltre che per le sue opere di grande successo, ha presentato presso la Cappella barocca dell’Istituto Italiano di Cultura la traduzione in lingua ceca, a cura di Marina Feltlová, del suo bestseller: Accabadora (Einaudi, 2009), vincitore dell’edizione 2010 del Premio Campiello e tradotto in più di venti lingue. Café Boheme l’ha incontrata per farle qualche domanda.
 CB. Una storia nata da un blog e che smaschera sottili meccanismi di manipolazione, un romanzo sulla morte e sulla maternità scelta, un libro-saggio sulla strumentalizzazione della figura di Maria e sulla donna in rapporto alla fede cattolica, una guida alternativa alla Sardegna…. Ogni tuo libro sembra scritto con mano diversa. Qual è il filo conduttore della tua scrittura?
CB. Una storia nata da un blog e che smaschera sottili meccanismi di manipolazione, un romanzo sulla morte e sulla maternità scelta, un libro-saggio sulla strumentalizzazione della figura di Maria e sulla donna in rapporto alla fede cattolica, una guida alternativa alla Sardegna…. Ogni tuo libro sembra scritto con mano diversa. Qual è il filo conduttore della tua scrittura?
MM. La necessità del momento, l’urgenza. Nel senso che forse siamo troppo abituati a immaginare che si debba stare dentro categorie. Io sicuramente ho bisogno di mantenere una dimensione crossover, non sono perfettamente a mio agio dentro il ruolo della romanziera, e infatti la scrittura che frequento di meno è quella narrativa pura. In Italia non esiste quasi la categoria del saggio divulgativo, colloquiale: esistono i toni accademici da una parte, ed esiste il romanzo dall’altra. Tutte le vie di mezzo sono libri ibridi per i quali non c’è neppure una definizione in libreria, sono l’incubo dei catalogatori e dei bibliotecari. Io, invece, in quello spazio misto mi trovo molto bene e penso anche di poter dare un contributo a certi dibattiti, proprio in virtù di questo melting pot tra un sapere narrativo, esperenziale, e una riflessione che si rifà ai miei studi accademici. Ne ho parlato molto con altri scrittori, con Marcello Fois, Francesco Piccolo, Antonio Pascale, con Domenico Starnone. Perché – a parte Marcello che scrive solo romanzi – gli altri tre stanno con sempre più evidenza spostando l’asse della loro scrittura verso quel genere di narrazione, passando per l’autofiction, e Pascale tra loro è il più vicino a quello che faccio io. Ci siamo chiesti se il romanzo sia finito, se non riusciamo più a scrivere romanzi perché ci sembra inadeguato rispetto alle esigenze del paese. Perché poi è questo il problema. Se hai una percezione politica della scrittura non puoi non essere crossover, perché la realtà è complessa e ti richiede risposte complesse, variegatissime, devi uscire dagli schemi e dalle caselle. Marcello dice che quello che io sto provando, e che anche gli altri stanno provando – cioè l’insufficienza del linguaggio letterario rispetto alle urgenze della realtà- sia una sorta di malattia esantematica degli scrittori giovani: pensare che il saggio, la parola contingente, possa agire sulla realtà in maniera più profonda di quanto non possa fare l’atto narrativo. Marcello mi dice: tu ricordati sempre che alla fine dei tempi Proust avrà cambiato il mondo molto più di Bauman e scrivere un romanzo che penetra l’immaginario è un atto politico più profondo che non scrivere un saggio ponderoso attinente al momento presente. Io di questa cosa sono in parte convinta, perché so quanto mi hanno cambiato la vita e la percezione del mondo alcuni romanzi. Tuttavia, alle volte, quando scrivo letteratura mi sento inutile rispetto al tempo presente.
CB. Al di là dei temi trattati, appare in Accabadora la tua volontà di descrivere una società, quella della Sardegna degli anni 50, molto diversa da quella attuale benché sia passato solo mezzo secolo; una società con codici diversi, un profondo senso di appartenenza, specifiche figure sociali e una diversa morale. Cosa ti affascina di quel tipo di società e cosa, secondo te,andrebbe recuperato?
MM. Tu dici sono passati solo 50 anni, in realtà il tempo in questi 50 anni è corso a una velocità spaventosa. La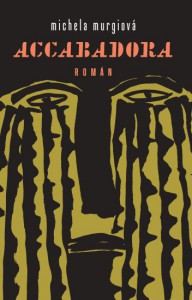 differenza culturale, storica, che c’era tra mia nonna e la mia bisnonna era minima: riproducevano lo stesso modello femminile quasi con lo stesso codice. Mentre la differenza tra mia madre e mia nonna è di 200 anni. Nel senso che mia nonna è del 1904, e veniva a un mondo identico a quello di duecento anni prima. Mia madre invece è del ’46, e aveva vent’anni nel ’68, quindi capisci il salto culturale, antropologico: l’accelerazione è stata davvero prepotente. In quegli anni si è generato uno strappo, una divaricazione, tra il modo di vedere il mondo della generazione precedente e quello della successiva. E questo strappo è stato semplicemente un taglio: loro la ricomposizione non potevano farla. La ricomposizione spetta alla mia generazione, quella venuta dopo: riconoscere il valore dell’esperienza materna, senza perdere il buono dell’esperienza dei nonni, dei bisnonni. So che è pericoloso dirlo, ma ecco cosa salverei: quello era un mondo in cui il soggetto collettivo era più forte di quello individuale, ed è un mondo al contrario rispetto a quello che noi viviamo. Io mi rendo conto del peso di quel modello. Per esempio da ragazzina pativo il fatto di dover rispondere a chiunque di quello che facevo. Chiunque poteva andare a dire a mia madre che mi aveva visto fare, dire, frequentare. Se rientravo la sera e c’erano le vecchine con le sedie fuori, sapevano a che ora tornavo e io sapevo che ne avrebbero parlato per tutta la settimana. E questo controllo collettivo, questa sorta di grande occhio che ti segue in ogni via, è oggettivamente pesante, anche perché deresponsabilizza: tutto quello che fai è inscritto dentro modelli decisi da una comunità, ed è molto difficile essere trasgressivi senza diventare emarginati. Al tempo stesso, però, mi sembra che l’altra risposta, quella di un individualismo assolutizzato, generi un altro genere di abissi che sono meno gestibili ancora. Ho molto più paura della solitudine dell’individuo che non del controllo della collettività. Credo che la sfida della nostra generazione sia mantenere il rispetto di se stessi senza perdere il senso di appartenenza a un soggetto plurale.
differenza culturale, storica, che c’era tra mia nonna e la mia bisnonna era minima: riproducevano lo stesso modello femminile quasi con lo stesso codice. Mentre la differenza tra mia madre e mia nonna è di 200 anni. Nel senso che mia nonna è del 1904, e veniva a un mondo identico a quello di duecento anni prima. Mia madre invece è del ’46, e aveva vent’anni nel ’68, quindi capisci il salto culturale, antropologico: l’accelerazione è stata davvero prepotente. In quegli anni si è generato uno strappo, una divaricazione, tra il modo di vedere il mondo della generazione precedente e quello della successiva. E questo strappo è stato semplicemente un taglio: loro la ricomposizione non potevano farla. La ricomposizione spetta alla mia generazione, quella venuta dopo: riconoscere il valore dell’esperienza materna, senza perdere il buono dell’esperienza dei nonni, dei bisnonni. So che è pericoloso dirlo, ma ecco cosa salverei: quello era un mondo in cui il soggetto collettivo era più forte di quello individuale, ed è un mondo al contrario rispetto a quello che noi viviamo. Io mi rendo conto del peso di quel modello. Per esempio da ragazzina pativo il fatto di dover rispondere a chiunque di quello che facevo. Chiunque poteva andare a dire a mia madre che mi aveva visto fare, dire, frequentare. Se rientravo la sera e c’erano le vecchine con le sedie fuori, sapevano a che ora tornavo e io sapevo che ne avrebbero parlato per tutta la settimana. E questo controllo collettivo, questa sorta di grande occhio che ti segue in ogni via, è oggettivamente pesante, anche perché deresponsabilizza: tutto quello che fai è inscritto dentro modelli decisi da una comunità, ed è molto difficile essere trasgressivi senza diventare emarginati. Al tempo stesso, però, mi sembra che l’altra risposta, quella di un individualismo assolutizzato, generi un altro genere di abissi che sono meno gestibili ancora. Ho molto più paura della solitudine dell’individuo che non del controllo della collettività. Credo che la sfida della nostra generazione sia mantenere il rispetto di se stessi senza perdere il senso di appartenenza a un soggetto plurale.
CB. E cosa recupereresti di questo mondo?
 MM. Gli spazi fisici. I piccoli paesi hanno dei luoghi che sono luoghi comuni in tutti i sensi possibili: comuni perché ci vanno tutti. Le piazze, gli spazi previsti proprio perché le persone si incontrino. La progettazione degli spazi urbani attuali è pensata per altre esigenze, non quelle relazionali. Per cui, poiché chi progetta spazi progetta comportamenti, è evidente che gli spazi moderni generano solitudini. Oggi in una città piccola come Oristano il sabato pomeriggio si esce per andare al centro commerciale, perché non esiste un altro luogo dove andare. Le piazze non ci sono più, se ci sono, sono chiuse al traffico, per cui se hai un bambino piccolo non fai due chilometri per andare al centro storico, vai al centro commmerciale perché c’è anche l’aria condizionata. È tutto ragionato per eliminare i luoghi di incontro. Se potessi recuperare qualcosa, recupererei il concetto di urbanistica come materia umanistica, luogo in cui vengono progettati modi di essere delle persone.
MM. Gli spazi fisici. I piccoli paesi hanno dei luoghi che sono luoghi comuni in tutti i sensi possibili: comuni perché ci vanno tutti. Le piazze, gli spazi previsti proprio perché le persone si incontrino. La progettazione degli spazi urbani attuali è pensata per altre esigenze, non quelle relazionali. Per cui, poiché chi progetta spazi progetta comportamenti, è evidente che gli spazi moderni generano solitudini. Oggi in una città piccola come Oristano il sabato pomeriggio si esce per andare al centro commerciale, perché non esiste un altro luogo dove andare. Le piazze non ci sono più, se ci sono, sono chiuse al traffico, per cui se hai un bambino piccolo non fai due chilometri per andare al centro storico, vai al centro commmerciale perché c’è anche l’aria condizionata. È tutto ragionato per eliminare i luoghi di incontro. Se potessi recuperare qualcosa, recupererei il concetto di urbanistica come materia umanistica, luogo in cui vengono progettati modi di essere delle persone.
CB.Quello che dici è molto pasoliniano. Anche Pasolini negli anni ’70 diceva: “stanno chiudendo le piazze”.
MM. Ma certo, pensa soltanto la politica: non ci sono più le sezioni di partito. Se tu chiudi le sezioni di partito stai dicendo ai militanti che il loro peso dentro la progettazione di quell’idea di mondo è totalmente ininfluente. Non ci sono luoghi di incontro dal basso. Che politica generi se chiudi le sezioni?
CB. Volendo tracciare un parallelo tra Accabadora e Ave Mary vediamo che in entrambi i libri parli di donne, di madri, ma anche di morte. Cosa ti ha spinto ad affrontare questo tema che, nella società odierna, si tende sempre più a esorcizzare e marginalizzare?
MM. La familiarità che ne ho, probabilmente. Appartengo a una generazione di bambini i cui genitori non hanno avuto paura di mostrare loro la morte. Io i miei morti li ho visti tutti, i miei nonni, i miei zii. Quando è morta mia nonna, invece, i miei nipoti non sono stati portati a vederla perché non si scioccassero. Io credo che questa cosa di continuare a considerare la morte come shock della vita sia priva di senso. Sul piano del femminismo, credo che il femminismo abbia colpevolmente trascurato il discorso della morte perché si è occupato prevalente della fase generativa della vita. È stata una reductio ad uterum, se vogliamo, perché era lì che si esercitava il controllo. In realtà, nel momento in cui ti sei ripreso la libertà della fecondità femminile, ti rendi conto che l’asse del controllo si è spostato da un’altra parte. La vecchiaia delle donne è un tempo terribile di scomparsa. Io adesso ho 42 anni. Più mi avvicino a quel tempo, più sento la necessità di strutturarmi, di organizzare il mio dissenso in quella direzione. In questo sono aiutata: Loredana Lipperini, Iaia Caputo, molte altre stanno facendo riflessioni analoghe, e dicono: attenzione, quello è un tempo pericoloso, perché è un tempo dimenticato. E chi cade in quel tempo, cade in un oblio, e le donne sono tre volte più fragili. Credo che riprenderci la morte e lo spazio della vecchiaia come spazio di potenza sia la cosa migliore da fare innanzitutto per noi stesse, ma anche per le nostre figlie che non vedono mai una vecchia che non sia rappresentata in modo caricaturale. In Ave Mary faccio molti esempi su questo punto perché si capisca cosa significa avere soltanto due immagini di donne vecchie rispettabili, Rita Levi Montalcini e Margherita Hack, e ora neanche più quelle. Parlo del meccanismo con cui, fuori dall’ambito in cui possono essere rispettate, si applica loro la stessa mannaia che tocca a qualunque persona anziana di sesso femminile, diversamente da quanto accade a un uomo. E finché non si prende coscienza di questo… È facile fare un discorso femminista su tette, culi, aborto: lì ci sono già dei linguaggi codificati. Farlo sulla morte e sulla vecchiaia è più arduo. Perché sono le donne stesse ad aver introiettato uno sguardo maschile che le vuole sempre seduttive. Il boom della chirurgia estetica non riguarda più la diva del cinema, riguarda la maestra delle elementari che va a farsi il botulino. Quando la negazione arriva a un livello così popolare significa che la rivoluzione che hai davanti è lunga, altro che Sessantotto.
avuto paura di mostrare loro la morte. Io i miei morti li ho visti tutti, i miei nonni, i miei zii. Quando è morta mia nonna, invece, i miei nipoti non sono stati portati a vederla perché non si scioccassero. Io credo che questa cosa di continuare a considerare la morte come shock della vita sia priva di senso. Sul piano del femminismo, credo che il femminismo abbia colpevolmente trascurato il discorso della morte perché si è occupato prevalente della fase generativa della vita. È stata una reductio ad uterum, se vogliamo, perché era lì che si esercitava il controllo. In realtà, nel momento in cui ti sei ripreso la libertà della fecondità femminile, ti rendi conto che l’asse del controllo si è spostato da un’altra parte. La vecchiaia delle donne è un tempo terribile di scomparsa. Io adesso ho 42 anni. Più mi avvicino a quel tempo, più sento la necessità di strutturarmi, di organizzare il mio dissenso in quella direzione. In questo sono aiutata: Loredana Lipperini, Iaia Caputo, molte altre stanno facendo riflessioni analoghe, e dicono: attenzione, quello è un tempo pericoloso, perché è un tempo dimenticato. E chi cade in quel tempo, cade in un oblio, e le donne sono tre volte più fragili. Credo che riprenderci la morte e lo spazio della vecchiaia come spazio di potenza sia la cosa migliore da fare innanzitutto per noi stesse, ma anche per le nostre figlie che non vedono mai una vecchia che non sia rappresentata in modo caricaturale. In Ave Mary faccio molti esempi su questo punto perché si capisca cosa significa avere soltanto due immagini di donne vecchie rispettabili, Rita Levi Montalcini e Margherita Hack, e ora neanche più quelle. Parlo del meccanismo con cui, fuori dall’ambito in cui possono essere rispettate, si applica loro la stessa mannaia che tocca a qualunque persona anziana di sesso femminile, diversamente da quanto accade a un uomo. E finché non si prende coscienza di questo… È facile fare un discorso femminista su tette, culi, aborto: lì ci sono già dei linguaggi codificati. Farlo sulla morte e sulla vecchiaia è più arduo. Perché sono le donne stesse ad aver introiettato uno sguardo maschile che le vuole sempre seduttive. Il boom della chirurgia estetica non riguarda più la diva del cinema, riguarda la maestra delle elementari che va a farsi il botulino. Quando la negazione arriva a un livello così popolare significa che la rivoluzione che hai davanti è lunga, altro che Sessantotto.
CB. L’osservatore romano, dalla penna di Lucetta Scarrafia ha criticato Ave Mary definendolo un libro “fatto di idee banali e che rivela una preparazione decisamente insufficiente sulla storia della Chiesa”. Questa posizione è stata condivisa da tutta la critica cattolica? Come rispondi alla Scarrafia?
 MM. In realtà è una posizione solo sua. Lucetta Scarrafia è una storica della Chiesa, non una teologa, il testo è stato rivisto ripetutamente dal coordinamento delle teologhe italiane, di cui Lucetta Scarrafia non fa parte. E questa è la risposta. Quel libro ha un respiro di collettività. È stato costruito come un investimento da parte della comunità delle teologhe italiane. Marinella Perroni, ringraziata nel libro, è uno dei deus ex machina di Ave Mary. C’era il desiderio di far migrare i temi della grande riflessione femminista intra muros, nella chiesa, in un registro popolare. Quando ho proposto il libro a Einaudi, la collocazione naturale, secondo la casa editrice, sarebbe stata nella collana della saggistica torinese. Abbiamo riflettuto, e io mi sono detta: ma se mi mettono tra Enzo Bianchi e Eugenio Scalfari, mia madre non lo leggerà mai, tutto quel bianco le farà paura, penserà di non capirlo. Perciò chiesi la collocazione in Stile libero, e con una copertina pop, dissacratoria. Volevo il giallo, volevo il fucsia, volevo un titolo sparato e una madonna in copertina, clamorosa, oleografica. Perché volevo che attirasse l’attenzione delle persone che comprano le pubblicazioni religiose e hanno quell’immaginario e ci si sentono comodi dentro. Il libro non era scritto per compiacere persone come Lucetta Scarrafia. È chiaro che dentro ci sono due capitoli molto pesanti, criticissimi, uno su Giovanni Paolo II, uno sulla visione di Ratzinger rispetto alle donne. Ma grazie a dio non ho una cattedra in una facoltà teologica, non ho cura d’anime, posso dire tutto quello che penso e assumermene la responsabilità. Per quanto riguarda il discorso della formazione teologica, la comunità dei teologi è varia e spesso dissonante, è fortunatamente uno dei pochi spazi di pensiero libero rimasto nella Chiesa. La mia voce ha lo stesso diritto di esprimersi di quella di Lucetta Scarrafia.
MM. In realtà è una posizione solo sua. Lucetta Scarrafia è una storica della Chiesa, non una teologa, il testo è stato rivisto ripetutamente dal coordinamento delle teologhe italiane, di cui Lucetta Scarrafia non fa parte. E questa è la risposta. Quel libro ha un respiro di collettività. È stato costruito come un investimento da parte della comunità delle teologhe italiane. Marinella Perroni, ringraziata nel libro, è uno dei deus ex machina di Ave Mary. C’era il desiderio di far migrare i temi della grande riflessione femminista intra muros, nella chiesa, in un registro popolare. Quando ho proposto il libro a Einaudi, la collocazione naturale, secondo la casa editrice, sarebbe stata nella collana della saggistica torinese. Abbiamo riflettuto, e io mi sono detta: ma se mi mettono tra Enzo Bianchi e Eugenio Scalfari, mia madre non lo leggerà mai, tutto quel bianco le farà paura, penserà di non capirlo. Perciò chiesi la collocazione in Stile libero, e con una copertina pop, dissacratoria. Volevo il giallo, volevo il fucsia, volevo un titolo sparato e una madonna in copertina, clamorosa, oleografica. Perché volevo che attirasse l’attenzione delle persone che comprano le pubblicazioni religiose e hanno quell’immaginario e ci si sentono comodi dentro. Il libro non era scritto per compiacere persone come Lucetta Scarrafia. È chiaro che dentro ci sono due capitoli molto pesanti, criticissimi, uno su Giovanni Paolo II, uno sulla visione di Ratzinger rispetto alle donne. Ma grazie a dio non ho una cattedra in una facoltà teologica, non ho cura d’anime, posso dire tutto quello che penso e assumermene la responsabilità. Per quanto riguarda il discorso della formazione teologica, la comunità dei teologi è varia e spesso dissonante, è fortunatamente uno dei pochi spazi di pensiero libero rimasto nella Chiesa. La mia voce ha lo stesso diritto di esprimersi di quella di Lucetta Scarrafia.
CB. Dal tuo primo romanzo Virzì ha tratto un film, Tutta la vita davanti. Pare che anche Accabadora arriverà sugli schermi col titolo L’ultima madre. La regia è di Emanuela Rizzotto, alla sua prima prova con un lungometraggio, questo film si farà? Quanto rispecchierà il libro o quanto sarà “liberamente tratto?”
MM. Dopo la prima esperienza cinematografica, ho scelto di non interessarmi più del destino delle traduzioni cinematografiche, e quindi a queste domande non ho una risposta vera e propria. Non ho voluto vedere la sceneggiatura, non so a che punto siano le cose. L’esperenza della traduzione cinematografica del mio primo libro mi ha fatto capire che il mio lavoro è un altro. Mettiamola così: i film preferisco andare a vederli al cinema.
CB. Qualche settimana fa è uscito sul Corriere della sera un articolo di Franco Cordelli dedicato alla letteratura degli ultimi 20 anni, scatenando una serie di accese discussioni e polemiche. Nella mappa di 70 autori contemporanei proposta da Cordelli sei stata inserita tra i conservatori, certo in buona compagnia, con Raffaele La Capria, Alfonso Berardinelli, ma unica quarantenne insieme a Matteo Marchesini, tra scrittori di generazioni distanti. Come ti senti in questo gruppo? Ti riconosci nella definizione?
MM. Credo che da parte di uno scrittore commentare le posizioni di un critico al suo riguardo sia proprio da finale di carriera. Chi l’ha fatto, ha sbagliato. Cordelli ha lanciato una provocazione in quella che lui ha definito palude. All’inzio potevo essere desiderosa di contrastare la sua lettura, ora più leggo gli interventi di risposta e più mi viene la tentazione di dargli ragione.
CB. Ma mi sorprendeva il fatto che tu fossi catalogata tra i conservatori…
M.M. Io mi considero un’esponente della letteratura sarda, e Cordelli neanche sa che esiste. Le categoria critiche con cui mi leggo io, non sono assolutamente quelle in cui mi inserisce lui. Facciamo un esempio, e non sto accostando cose inaccostabili. Essendo letta nel quadro della letteratura italiana, per molto tempo Grazia Deledda è stata percepita come un’anomalia dissonante, una specie di Nobel sbagliato: il postino lo stava portando a Pirandello, ma poi si è confuso, ed è finito in un’altra isola, in Sardegna, per darlo alla Deledda che non c’entrava nulla. Questa è più o meno la lettura ipersemplificata che la critica italiana ha sempre dato di questa scrittrice. È chiaro che se leggi Grazia Deledda confrontandola con la letteratura italiana non la capisci. Guardala invece nello spettro europeo. Canne al vento e Cime tempestose sono due libri del tutto analoghi, per linguaggio, per trama, per temi, per visione. Canne al vento è un libro potentemente sovversivo, perché mette in scena due rovesciamenti: il servo uccide il padrone, la figlia si ribella al padre. Due sistemi, quello sociale e quello familiare, vengono sovvertiti dentro la narrazione. Come fai a non studiarla in rapporto agli scrittori europei che hanno fatto la stessa cosa? Se l’accosti a Pirandello non capisci: sono due registri, due generi d’arte totalmente differenti. Io ho l’impressione che i critici italiani non possano fare a meno di ricondurre anche scritture come quelle sarde alle loro logiche, alle loro categorie. E dentro queste categorie noi risultiamo atipici, classici a quarant’anni. Questo voleva dire Cordelli: stai dentro uno schema molto codificato, e dal suo punto di vista non era esattamente un complimento. In ogni caso quella catalogazione è evidente che fa capo a un solo libro, Accabadora. Allo stesso modo è difficile giudicare Giorgio Falco estrapolando una sola frase: la sua è una delle scritture più potenti della mia generazione. Lo stesso vale per Giorgio Vasta… Un giorno Asor Rosa definì la scrittura mia, di Giorgio Vasta e di un altro autore che non ricordo, ma comunque proveniente da Roma in giù, La rivincita delle scritture di periferia, così si intitolava l’articolo. Noi non rispondemmo. Ma rispetto a quale baricentro noi saremmo periferia? È evidente che c’è un problema di autocentrismo.
con cui mi leggo io, non sono assolutamente quelle in cui mi inserisce lui. Facciamo un esempio, e non sto accostando cose inaccostabili. Essendo letta nel quadro della letteratura italiana, per molto tempo Grazia Deledda è stata percepita come un’anomalia dissonante, una specie di Nobel sbagliato: il postino lo stava portando a Pirandello, ma poi si è confuso, ed è finito in un’altra isola, in Sardegna, per darlo alla Deledda che non c’entrava nulla. Questa è più o meno la lettura ipersemplificata che la critica italiana ha sempre dato di questa scrittrice. È chiaro che se leggi Grazia Deledda confrontandola con la letteratura italiana non la capisci. Guardala invece nello spettro europeo. Canne al vento e Cime tempestose sono due libri del tutto analoghi, per linguaggio, per trama, per temi, per visione. Canne al vento è un libro potentemente sovversivo, perché mette in scena due rovesciamenti: il servo uccide il padrone, la figlia si ribella al padre. Due sistemi, quello sociale e quello familiare, vengono sovvertiti dentro la narrazione. Come fai a non studiarla in rapporto agli scrittori europei che hanno fatto la stessa cosa? Se l’accosti a Pirandello non capisci: sono due registri, due generi d’arte totalmente differenti. Io ho l’impressione che i critici italiani non possano fare a meno di ricondurre anche scritture come quelle sarde alle loro logiche, alle loro categorie. E dentro queste categorie noi risultiamo atipici, classici a quarant’anni. Questo voleva dire Cordelli: stai dentro uno schema molto codificato, e dal suo punto di vista non era esattamente un complimento. In ogni caso quella catalogazione è evidente che fa capo a un solo libro, Accabadora. Allo stesso modo è difficile giudicare Giorgio Falco estrapolando una sola frase: la sua è una delle scritture più potenti della mia generazione. Lo stesso vale per Giorgio Vasta… Un giorno Asor Rosa definì la scrittura mia, di Giorgio Vasta e di un altro autore che non ricordo, ma comunque proveniente da Roma in giù, La rivincita delle scritture di periferia, così si intitolava l’articolo. Noi non rispondemmo. Ma rispetto a quale baricentro noi saremmo periferia? È evidente che c’è un problema di autocentrismo.
CB. È noto il tuo impegno in politica, alle ultime elezioni ti sei candidata con Sardegna Possibile. Un articolo del Fatto quotidiano titolava Il fenomeno Michela Murgia e il silenzio dei media, rendendo conto del modo partecipativo di far politica da voi proposto e denunciando nel contempo l’indifferenza dei giornalisti. Forse anche per questo noi, italiani e non, di indipendenza sarda ne sappiamo poco. Potresti spiegarci le ragioni di questa esigenza?
 MM. Non sono ragioni nazionalistiche. Ti potrei dire che siamo stati indipendenti fino al 1400, ma non è un motivo: se anche non avessimo avuto un solo giorno di libertà nel nostro passato, questo non precluderebbe la possibilità di averlo nel futuro. Esistono delle peculiarità culturali e storiche che fanno di noi una nazione, una serie di codici che sono il nostro patrimonio condiviso. Questo non implica necessariamente un’indipendenza politica, ma il riconoscimento dello statuto speciale in qualche modo è già un ammettere che ci sono delle condizioni. Per me le ragioni sono esclusivamente geopolitiche. La Sardegna è un’isola con delle esigenze e dei bisogni molto precisi che quasi mai coincidono con quelli della nazione italiana. Sono esigenze di pianificazione economica di un certo tipo. Noi abbiamo bisogno di una serie di scelte che in questo momento sono opposte a quelle di cui ha bisogno l’Italia. L’Italia ha bisogno di energia, e ha deciso che la Sardegna è un buon posto dove produrla. La Sardegna ha bisogno di agricoltura, perché importa il 75% di quello che mangia. Non sono cifre dette a caso. Un posto dove tu pianti un sasso e cresce un olivo importa il 75% di quello che mangia. Per noi l’accesso alla sovranità alimentare è un’azione politica fortissima. Ma come realizzarla se il piano energetico italiano prevede per la Sardegna la ricerca di idrocarburi nel sottosuolo, l’autorizzazione piuttosto corsara di una serie di progetti di produzione di energia cosiddetta verde, nel senso che i pannelli solari non inquinano mentre producono, ma il loro smaltimento è molto impattante? E nel frattempo si occupa suolo agricolo. Chi può prendere questa decisione? Soltanto un popolo che ha una sua soggettività politica completa. Francesco Pigliaro, il nostro governatore, va a negoziare con Renzi per chiedergli per favore di rimuovere le basi… Il 60% delle basi militari italiane si trova in Sardegna, con tutto quello che ciò significa in termini di economia mancata. Tu lì non fai turismo, non fai agricoltura, non ci vivi nemmeno. Le basi sono state costruite in posti a bassissima presenza umana proprio per evitare situazioni di contrasto e di forte resistenza. Se non ci fosse stata Fukushima, la Sardegna era in predicato per ospitare quattro centrali nucleari, sotto Scajola, perché la prospettiva che offriva era: poca gente, acqua intorno e nessun rischio sismico. Eravamo l’ideale. Che strumento politico avremmo avuto per opporci? Nessuno. Perché l’interesse del popolo italiano è sovrano rispetto all’interesse sardo, ma anche all’interesse della val di Susa… Esiste una privazione dei territori del diritto all’autodeterminazione. Per cui il discorso che faccio è politico. Ti faccio un esempio: la pianificazione del piano trasporti italiano. Cagliari non è un hub, ciò significa che non sono previsti voli diretti per il mondo. Ma anche per andare a Napoli devo fare Cagliari- Roma-Napoli. C’è un volo diretto per Parigi, perché ci sono i low cost che ci consentono una continuità territoriale che i patti con le compagnie di bandiera non prevedono. Per noi gli spostamenti sono un fattore determinante del sottosviluppo commerciale. È un costo faticoso da sostenere, un peso molto rilevante. Fai poi il caso dell’Europa. Noi siamo nel collegio isole. La Sicilia ha tre volte i nostri abitanti. Per noi la possibilità di eleggere un rappresentante non è contemplata se non all’interno di patti tra partiti. Il Pd quest’anno ha scelto che Renato Soru fosse l’uomo di punta: se non si candidava l’anno prima alle elezioni regionali, sarebbe stato in corsia preferenziale per Bruxelles. Lui su questo punto ha tentennato fino all’ultimo. Alla fine non si è candidato alle regionali e alle europee ha preso tanti voti in Sicilia perché il PD ha fatto un patto, saldando il proprio debito. Ma la Sardegna può essere rappresentata in Europa in base agli accordi che il PD prende per fatti suoi? Se questo accordo non ci fosse stato, i voti di tutti i sardi non sarebbero bastati a mandare un sardo a Bruxelles. Ovviamente la mia prospettiva è che la Sardegna sia rappresentata in Europa con i suoi sei parlamentari, esattamente come Malta.
MM. Non sono ragioni nazionalistiche. Ti potrei dire che siamo stati indipendenti fino al 1400, ma non è un motivo: se anche non avessimo avuto un solo giorno di libertà nel nostro passato, questo non precluderebbe la possibilità di averlo nel futuro. Esistono delle peculiarità culturali e storiche che fanno di noi una nazione, una serie di codici che sono il nostro patrimonio condiviso. Questo non implica necessariamente un’indipendenza politica, ma il riconoscimento dello statuto speciale in qualche modo è già un ammettere che ci sono delle condizioni. Per me le ragioni sono esclusivamente geopolitiche. La Sardegna è un’isola con delle esigenze e dei bisogni molto precisi che quasi mai coincidono con quelli della nazione italiana. Sono esigenze di pianificazione economica di un certo tipo. Noi abbiamo bisogno di una serie di scelte che in questo momento sono opposte a quelle di cui ha bisogno l’Italia. L’Italia ha bisogno di energia, e ha deciso che la Sardegna è un buon posto dove produrla. La Sardegna ha bisogno di agricoltura, perché importa il 75% di quello che mangia. Non sono cifre dette a caso. Un posto dove tu pianti un sasso e cresce un olivo importa il 75% di quello che mangia. Per noi l’accesso alla sovranità alimentare è un’azione politica fortissima. Ma come realizzarla se il piano energetico italiano prevede per la Sardegna la ricerca di idrocarburi nel sottosuolo, l’autorizzazione piuttosto corsara di una serie di progetti di produzione di energia cosiddetta verde, nel senso che i pannelli solari non inquinano mentre producono, ma il loro smaltimento è molto impattante? E nel frattempo si occupa suolo agricolo. Chi può prendere questa decisione? Soltanto un popolo che ha una sua soggettività politica completa. Francesco Pigliaro, il nostro governatore, va a negoziare con Renzi per chiedergli per favore di rimuovere le basi… Il 60% delle basi militari italiane si trova in Sardegna, con tutto quello che ciò significa in termini di economia mancata. Tu lì non fai turismo, non fai agricoltura, non ci vivi nemmeno. Le basi sono state costruite in posti a bassissima presenza umana proprio per evitare situazioni di contrasto e di forte resistenza. Se non ci fosse stata Fukushima, la Sardegna era in predicato per ospitare quattro centrali nucleari, sotto Scajola, perché la prospettiva che offriva era: poca gente, acqua intorno e nessun rischio sismico. Eravamo l’ideale. Che strumento politico avremmo avuto per opporci? Nessuno. Perché l’interesse del popolo italiano è sovrano rispetto all’interesse sardo, ma anche all’interesse della val di Susa… Esiste una privazione dei territori del diritto all’autodeterminazione. Per cui il discorso che faccio è politico. Ti faccio un esempio: la pianificazione del piano trasporti italiano. Cagliari non è un hub, ciò significa che non sono previsti voli diretti per il mondo. Ma anche per andare a Napoli devo fare Cagliari- Roma-Napoli. C’è un volo diretto per Parigi, perché ci sono i low cost che ci consentono una continuità territoriale che i patti con le compagnie di bandiera non prevedono. Per noi gli spostamenti sono un fattore determinante del sottosviluppo commerciale. È un costo faticoso da sostenere, un peso molto rilevante. Fai poi il caso dell’Europa. Noi siamo nel collegio isole. La Sicilia ha tre volte i nostri abitanti. Per noi la possibilità di eleggere un rappresentante non è contemplata se non all’interno di patti tra partiti. Il Pd quest’anno ha scelto che Renato Soru fosse l’uomo di punta: se non si candidava l’anno prima alle elezioni regionali, sarebbe stato in corsia preferenziale per Bruxelles. Lui su questo punto ha tentennato fino all’ultimo. Alla fine non si è candidato alle regionali e alle europee ha preso tanti voti in Sicilia perché il PD ha fatto un patto, saldando il proprio debito. Ma la Sardegna può essere rappresentata in Europa in base agli accordi che il PD prende per fatti suoi? Se questo accordo non ci fosse stato, i voti di tutti i sardi non sarebbero bastati a mandare un sardo a Bruxelles. Ovviamente la mia prospettiva è che la Sardegna sia rappresentata in Europa con i suoi sei parlamentari, esattamente come Malta.
CB. Quello che proponete può essere anche un modello per un modo diverso di stare in Europa? Quello che dici ad esempio riguardo alla politica agricola in fondo vale non solo per la Sardegna…
MM. Secondo me è l’unico modo in cui l’Europa può essere pensata. La forma stato è l’unica foma di soggettività pienamente potente che noi riconosciamo, ma io non credo che in futuro sarà quella. L’indipendenza verso cui andiamo avrà probabilmente un’altra natura. Alcune di queste strade noi le stiamo già sperimentando ora, attraverso una serie di patti e accordi commerciali e culturali con altre nazioni senza stato e che di fatto costituiscono già le relazioni dell’Europa che verrà. Abbiamo rapporti con gli scozzesi, i catalani, nonché con i baschi, perché anche loro, da quando hanno scelto di abbandonare la lotta armata, meritano di essere considerati come interlocutori. I patti tra questi popoli sono la rete dell’Europa che verrà. Tsipras è stato un primo passaggio, ma a mio parere quel progetto non ha abbastanza struttura. Quello catalano, Podemos, può essere straordinariamente più forte.
CB. Quello del rapporto tra intellettuali e impegno civile è un tema certamente non nuovo. Secondo te, quale dovere morale ha – se ce l’ha – uno scrittore, un intellettuale, nei confronti della società in cui vive?
MM. Ho un difetto di formazione, in questo senso, sono gramsciana. Per me non esiste un altro modo di essere intellettuale, il che non è un giudizio per chi ha un altro approccio. Gramsci diceva che l’intellettuale è proprio il grado di congiunzione tra l’elemento popolare e l’elemento sovrastrutturale. L’intellettuale è pontefice. O li fai i ponti o non li fai… L’immagine del ponte è un’immagine forte. Ne parla Riccardo Sgreva dell’Università di Padova, il massimo esperto di storytelling politico, vale a dire delle arti della narrazione applicate alla comunicazione politica. Sgreva parla di ponte narrativo, della capacità del politico di costruire una storia, che si ferma a metà, verso la quale le storie delle persone vanno e si incontrano in un punto che è il punto del consenso. È il punto del consenso, ma non è il punto del voto: è il punto di riconoscimento di uno spazio comune tra la storia che tu stai proponendo, che è la tua, e il modo in cui le nostre possono riconoscersi all’interno di un progetto, che tu incarni in senso politico, ma che noi incarniamo in senso sociale, umano. Sgreva costruisce tutta una teorizzazione su come il linguaggio, le arti della narrazione possono creare questo ponte, o la prima parte di questo ponte, per andare a intercettare l’altra metà. In questo senso un intellettuale che lavora con le parole è naturalmente politico. Perché questo è il tempo della narrazione. Non è rimasto altro: se non hai più le piazze, non hai più i bar, non hai più gli spazi comuni, cos’altro ti rimane se non le storie? Dentro le storie tu puoi ricreare lo spazio in cui le persone si possono ri-conoscere, e ciò significa che non ti puoi esimere, altrimenti fai davvero il décor du régime. Alcuni mi dicono: L’atto più politico che possiamo fare è scrivere buone storie. Io però credo che non basti, bisogna avere la consapevolezza che quella buona storia è mezzo ponte.
CB. Nell’introduzione a una tua intervista sei stata definita: “Uno dei prodotti sardi d’esportazione che più funzionano negli anni 2000”. Negli ultimi anni, infatti, la Sardegna sta puntando moltissimo, oltre che alla valorizzazione dei suoi prodotti eno-gastronomici, anche sulle sue risorse intellettuali, vale a dire scrittori, artisti, musicisti… Dietro questo fenomeno c’è un progetto oppure è un fenomeno spontaneo?
 MM. La Sardegna non sta puntando assolutamente nulla sulla cultura, anzi. È il luogo oggetto di maggiori tagli. Se parli della politica, ti dico che l’amministrazione non crede nella cultura. È vero che noi siamo forti. Per una serie di fortune, anche commerciali, abbiamo acquisito il potere di organizzarci e di proteggere i soggetti fragili che sorgono ora e che hanno bisogno di essere accompagnati, di difenderci e difendere. Liberos è nato per questo: un network che sorge sulla base di un codice etico, per proteggersi dalle anomalie di mercato. Esiste ancora la convinzione che il mercato si possa autoregolare. Il nostro attuale presidente della regione è un economista con posizioni fortemente liberiste. Quando era ancora professore di economia, ricordo di avere avuto una discussione con lui proprio su Liberos. Mi chiamò e mi disse: “Quello che state facendo non è buono, perché state cercando di mettere una regola etica al mercato.” Questo perché nel codice di Liberos c’è una cosa che può essere passibile di obiezione da parte dell’Antitrust. I librai di un’intera regione si mettono d’accordo per non applicare lo sconto deciso dall’editore, uno sconto del 25% che azzera il loro guadagno. L’editore ha il potere, in quanto soggetto di mercato forte, di chiedere a tutti i librai di Sardegna di lavorare gratis per quel libro. Questo secondo noi non è etico, per cui se i librai si mettono d’accordo che quello sconto non si fa, non si fa e basta, e lo si spiega anche al lettore. Lui diceva: così i lettori di Sardegna saranno gli unici di tutta Italia a non poter accedere a quello sconto, quindi voi li state danneggiando. Ok, ma questo è il ragionamento di Marchionne. Io sto in un mercato dove le macchine di questo tipo hanno questo costo perché in Corea le producono pagando l’operaio una certa cifra. Qui il costo del lavoro è più alto, ma noi non possiamo vendere una macchina più cara degli altri perché chi la compra ci rimette. Ma chi compra deve sapere che il prezzo basso è determinato dall’abbassamento del livello dei diritti dell’operaio in Corea. Il lettore deve sapere che quello sconto gli viene applicato sacrificando la sopravvivenza del libraio. Perché rinunciare a questa valenza etica anche nelle questioni commerciali? È vero che noi produciamo oggetti che poi vengono venduti, però è ugualmente vero che le economie, marxianamente, determinano molta parte dei meccanismi della società. Per noi i librai non sono commercianti qualunque. Se chiude una libreria nel cuore della Barbagia significa che un ragazzino di 16 anni per comprarsi un libro dovrà fare 80 chilometri, e non li farà. Stai determinando la diminuzione degli strumenti democratici a disposizione delle persone. Non è soltanto questione di belle o cattive storie, o di storie a buon mercato. Tu stai aprendo la strada al colosso Amazon. La Francia in questo senso si difende. Aurélie Filippetti è il mio idolo. Lei da ministro della cultura ha deciso: le librerie sono un bene culturale, l’affitto glielo paghiamo noi. Gli altri commercianti si sono ribellati, dicendo: ma come, sono anche loro commercianti. E invece no: i librai costruiscono relazioni di prossimità. Una libreria in un quartiere non fa la stessa cosa che fa una merceria. È un luogo di altra natura che ha sì alcuni elementi commerciali, di mercato, ma ha anche una serie di elementi sociali che lo stato deve riconoscere. Per me questa cosa è automatica. In Italia dici una cosa del genere e i sindacati ti aprono un contenzioso perché stai privilegiando una categoria rispetto a un’altra. In Sardegna noi e la nostra consapevolezza abbiamo fatto sì che ci autorganizzassimo in una struttura per impedire questa deriva. Ma se aspettiamo la politica scatta una guerra tra poveri per prendere due contributi, come succede dappertutto, e non ne esci più.
MM. La Sardegna non sta puntando assolutamente nulla sulla cultura, anzi. È il luogo oggetto di maggiori tagli. Se parli della politica, ti dico che l’amministrazione non crede nella cultura. È vero che noi siamo forti. Per una serie di fortune, anche commerciali, abbiamo acquisito il potere di organizzarci e di proteggere i soggetti fragili che sorgono ora e che hanno bisogno di essere accompagnati, di difenderci e difendere. Liberos è nato per questo: un network che sorge sulla base di un codice etico, per proteggersi dalle anomalie di mercato. Esiste ancora la convinzione che il mercato si possa autoregolare. Il nostro attuale presidente della regione è un economista con posizioni fortemente liberiste. Quando era ancora professore di economia, ricordo di avere avuto una discussione con lui proprio su Liberos. Mi chiamò e mi disse: “Quello che state facendo non è buono, perché state cercando di mettere una regola etica al mercato.” Questo perché nel codice di Liberos c’è una cosa che può essere passibile di obiezione da parte dell’Antitrust. I librai di un’intera regione si mettono d’accordo per non applicare lo sconto deciso dall’editore, uno sconto del 25% che azzera il loro guadagno. L’editore ha il potere, in quanto soggetto di mercato forte, di chiedere a tutti i librai di Sardegna di lavorare gratis per quel libro. Questo secondo noi non è etico, per cui se i librai si mettono d’accordo che quello sconto non si fa, non si fa e basta, e lo si spiega anche al lettore. Lui diceva: così i lettori di Sardegna saranno gli unici di tutta Italia a non poter accedere a quello sconto, quindi voi li state danneggiando. Ok, ma questo è il ragionamento di Marchionne. Io sto in un mercato dove le macchine di questo tipo hanno questo costo perché in Corea le producono pagando l’operaio una certa cifra. Qui il costo del lavoro è più alto, ma noi non possiamo vendere una macchina più cara degli altri perché chi la compra ci rimette. Ma chi compra deve sapere che il prezzo basso è determinato dall’abbassamento del livello dei diritti dell’operaio in Corea. Il lettore deve sapere che quello sconto gli viene applicato sacrificando la sopravvivenza del libraio. Perché rinunciare a questa valenza etica anche nelle questioni commerciali? È vero che noi produciamo oggetti che poi vengono venduti, però è ugualmente vero che le economie, marxianamente, determinano molta parte dei meccanismi della società. Per noi i librai non sono commercianti qualunque. Se chiude una libreria nel cuore della Barbagia significa che un ragazzino di 16 anni per comprarsi un libro dovrà fare 80 chilometri, e non li farà. Stai determinando la diminuzione degli strumenti democratici a disposizione delle persone. Non è soltanto questione di belle o cattive storie, o di storie a buon mercato. Tu stai aprendo la strada al colosso Amazon. La Francia in questo senso si difende. Aurélie Filippetti è il mio idolo. Lei da ministro della cultura ha deciso: le librerie sono un bene culturale, l’affitto glielo paghiamo noi. Gli altri commercianti si sono ribellati, dicendo: ma come, sono anche loro commercianti. E invece no: i librai costruiscono relazioni di prossimità. Una libreria in un quartiere non fa la stessa cosa che fa una merceria. È un luogo di altra natura che ha sì alcuni elementi commerciali, di mercato, ma ha anche una serie di elementi sociali che lo stato deve riconoscere. Per me questa cosa è automatica. In Italia dici una cosa del genere e i sindacati ti aprono un contenzioso perché stai privilegiando una categoria rispetto a un’altra. In Sardegna noi e la nostra consapevolezza abbiamo fatto sì che ci autorganizzassimo in una struttura per impedire questa deriva. Ma se aspettiamo la politica scatta una guerra tra poveri per prendere due contributi, come succede dappertutto, e non ne esci più.
Di Letizia Kostner e Mauro Ruggiero